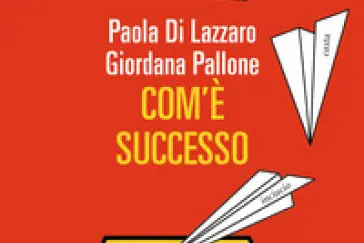PHOTO
Fandando Libri
«Le faccende umane si trovano, per unanime consenso, in uno stato deplorevole. Questa peraltro non è una novità. Per quanto indietro si riesca a guardare, esse sono sempre state in uno stato deplorevole». Il giudizio impietoso è l’incipit di un libretto, “Le leggi fondamentali della stupidità umana” di Carlo M. Cipolla, che è diventato un classico per così tanti lettori da far dubitare che in un gruppo così esteso non si nasconda qualcuno che a quelle leggi sottostia, pur avendolo sui propri scaffali. Come sornione imbeccava qualche giorno fa Adriano Sofri, che ne recensiva la ripubblicazione, non rassegnandosi pure a suggerire la sensazione «che non si sia mai stati stupidi come oggi, e che domani lo si sarà di più, e così via».
A rispondere a tanta sconsolatezza sul presente in cui siamo immersi e sulla sua cronaca, che lo annebbia giorno dopo giorno nella rincorsa collettiva della novità quotidiana, torna utile il passato, in cui pure eravamo immersi ma che è oggi facile dimenticare. Per evitare le lusinghe dell’oblio, occorre rispolverare quegli strumenti che l’attualità pare così disabituata a frequentare: la critica e il dibattito. E la fortuna editoriale vuole che questo sia il caso di “Com’è successo. Una repubblica in crisi, parola per parola”, nuova pubblicazione di Fandango Libri a firma di Paola Di Lazzaro e Giordana Pallone.
È lunga la sfilza dei com’è successo che si chiedono le due studiose. Lunga e comune a tante conversazioni del millennio che viviamo: com’è che “politico” è diventato un insulto, come dirsi “né di destra né di sinistra” è diventato un valore in cui riconoscersi, come i diritti sociali sono diventati privilegi e la condizione di vulnerabilità una colpa, come uno sconosciuto all’opinione pubblica è diventato Presidente del Consiglio, come i tagli alla spesa pubblica e lo smantellamento dello stato sociale sono il destino ineluttabile delle politiche recenti?
La materia dell’indagine del saggio è l’avvelenamento dei pozzi della politica e dell’informazione, il metodo è quello archeologico. A tale frana di com’è successo si risponde «voltandosi indietro e cercando di rifare la strada al contrario, per capire questa trasformazione politica e culturale. E le tracce più evidenti sono da riconoscere nel linguaggio. E nei suoi mutamenti». E che non si sta davanti a un predicare vago, le due autrici lo dimostrano tenendo ferma una tesi limpida e insieme disorientante nel contesto di una comunicazione pubblica sempre più parossistica, com’è la nostra: che la semplificazione del linguaggio sia una semplificazione dei processi democratici e della vita pubblica. Seguiamo un loro esempio, su una parola che corre di bocca in bocca da almeno quindici anni e che è il precipitato lessicale perfetto del malcontento diffuso nei confronti della classe politica. “La Casta”, lemma fra i più illustri all’interno del vocabolario delle distorsioni dell’opinione pubblica, le cui vicende fortunate stanno a dimostrare «come siano minate l’autorevolezza, la funzionalità e il ruolo del sistema pubblico attraverso l’uso continuo di termini denigratori e spregiativi riferiti ai componenti le istituzioni e alle istituzioni stesse». Già, ma come? Ecco che il saggio lo illustra spostando le lancette dei suoi lettori indietro: «È il 18 ottobre 2011, gli italiani da qualche mese hanno imparato a convivere e a familiarizzare con un termine che sino ad allora era rimasto confinato nel perimetro ristretto degli addetti ai lavori: “spread”, una parola inglese che in gergo finanziario indica il differenziale tra il rendimento dei titoli di Stato tedeschi e quelli dei vari paesi dell’Unione. Nei fatti, per l’opinione pubblica, quei numeretti equivalgono a un termometro e dall’inizio dell’estate 2011 quel termometro segna quota 200 punti base: una febbre medio- alta per i conti pubblici italiani. Lo spettro è quello del default, o per dirla con il pensiero comune di “finire come la Grecia”. Questa premessa è necessaria per capire come, nonostante l’economia mondiale e quindi anche italiana dal 2008 in poi fosse stata messa a soqquadro, in quel giorno di ottobre, poche settimane prima della crisi del governo Berlusconi IV, in una seguitissima puntata di Ballarò ( oltre 4 milioni di ascoltatori) il conduttore Giovanni Floris presentava i risultati di un sondaggio illustrando quale dovesse essere secondo gli italiani “l’intervento prioritario contro la crisi”. Ce ne sono di cose su cui dividersi, commenterà Francesco Costa sull’inserto domenicale del Sole 24 Ore: “Spendere per rilanciare i consumi o tagliare la spesa per ridurre le tasse? Alzare o no l’età pensionabile? Privatizzare o nazionalizzare? Nessuna di queste ipotesi è in testa al sondaggio. Ottiene invece il 61% questa proposta: la riduzione del numero dei parlamentari. Un altro 10% sosteneva, invece, che per uscire dalla crisi bisognasse subito “abolire le province”».
E ancora: se i cambiamenti di esecutivo avvenuti senza scioglimento delle Camere sono “governi non eletti dagli italiani”, se la magistratura è “il covo delle toghe rosse” e la giustizia è “a orologeria”, se il mondo dell’informazione è dominato da “professoroni”, se l’immigrazione è “una pacchia da far finire”, le Ong del soccorso sono “taxi del mare” e i poveri sono “fannulloni sul divano”, se insomma - come nel saggio è ricostruito tanto dettagliatamente - è l’intero linguaggio pubblico che si è corazzato contro la realtà, che ne è della capacità di intenderla, quella povera realtà?
La diagnosi che consegna ai lettori il saggio è amara e chiarissima: se si forza il linguaggio pubblico sempre verso l’iperbole, si rimane senza parole per comprendere e quindi intervenire sulle vicende della vita collettiva. Come potrà succedere che una simile usura, che è oggi la nostra lingua dominante, torni in un gioco fertile, sottratto ai luoghi comuni e alle sette culturali, è la domanda che questo libro consegna ai suoi lettori. Se non si vuole una vita democratica stupida, o ancora più stupida, occorre rispondere.