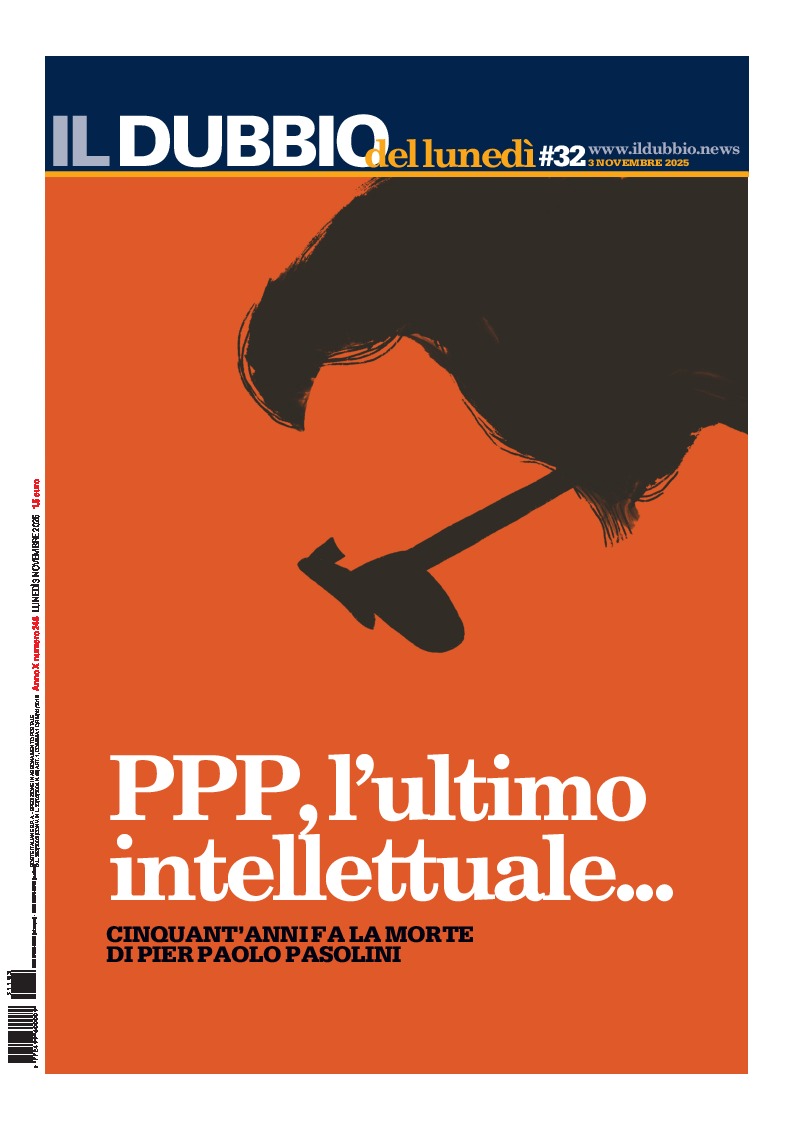PHOTO
FABIO PINELLI CSM
È un discorso che vale come cartina di tornasole della sfida che attende il sistema giudiziario quello che il vice presidente del Csm Fabio Pinelli ha tenuto a Venezia, all’assemblea dell’Unione Triveneta. Non si tratta soltanto di difendere prerogative costituzionali, ma di mettere in fila priorità pratiche — tempi processuali, funzioni dell’azione penale, struttura degli uffici, formazione e tecnologia — per restituire alla giustizia la sua natura di servizio ai cittadini, non di spettacolo politico.
La premessa è insieme culturale e politica. Come ricordava Pinelli citando Aldo Moro, «c’è una differenza tra semplificare e banalizzare. Nella operazione di semplificazione si elimina il superfluo, in quella di banalizzazione si elimina l’essenziale. Arduo, quando non impossibile, affrontare il tema giustizia, nella sua complessità, senza “scivolare” nella superficialità». Un monito che orienta tutto l’intervento: le riforme non vanno trattate come slogan, ma valutate per il loro impatto reale sul servizio giustizia.
Autonomia, separazione dei poteri e prudenza riformatrice
Al centro resta il principio fondamentale della separazione dei poteri. Pinelli non si limita a difendere il principio in astratto: ricorda che «l’autonomia e l’indipendenza della magistratura rappresentano prerogative irrinunciabili, poiché sono le basi del principio inderogabile dell’uguaglianza di tutti di fronte alla legge, principio rispetto al quale nessun arretramento può essere consentito». Allo stesso tempo avverte che «dalla fisiologica tensione tra poteri, politico e giudiziario, non si deve passare allo scontro e alla frattura istituzionale; fa male al Paese e le conseguenze le pagano innanzitutto i cittadini». È un appello alla responsabilità reciproca: le riforme possono essere legittime, ma il dibattito non può degenerare in una campagna contro la magistratura stessa.
Sull’onda delle novità correnti, Pinelli valuta la separazione delle carriere come «una legittima scelta di politica costituzionale condotta secondo criteri di “rappresentanza” che devono essere riconosciuti alla politica», ma ammonisce sul rischio di trasformare la discussione in un referendum sulla magistratura. Qui la sua posizione è di prudenza istituzionale: la politica può decidere, ma servono salvaguardie e chiarezza di regole per non comprimere garanzie.
Il paradosso processuale: «udienza Caronte» e la pena del processo
Il discorso entra poi nel merito processuale, evidenziando contraddizioni pratiche: l’udienza preliminare che avrebbe dovuto filtrare i procedimenti finisce per essere una «udienza Caronte» che traghetta troppi fascicoli verso il dibattimento. Pinelli descrive la dinamica con nettezza: «Tale criticità è all’origine del paradosso di una “udienza preliminare” che, da un lato, si vede formalmente arricchita di regole di giudizio sempre più stringenti (sostanzialmente anticipatrici della futura condanna) e, dall’altro, si dimostra nei fatti come una sorta di “udienza Caronte”, che traghetta un numero sempre maggiore di procedimenti verso il dibattimento, smentendo le finalità cui tali regole erano orientate».
Da qui la constatazione del peso della cosiddetta pena del processo: tempi lunghi, filtri inefficaci, costi per l’indagato e per la collettività. La proposta implicita è chiara: occorrono strumenti che responsabilizzino le scelte della pubblica accusa e rafforzino filtri effettivi, senza scaricare il lavoro delle scelte politiche sulla magistratura.
Gigantismo penale e la perdita del primato della libertà
Una delle pagine più nette del discorso è l’avvertimento sul ricorso smodato al penale: «Abbiamo smarrito il primato della libertà individuale. Dobbiamo affrontare un vero e proprio gigantismo penale, frutto della moltiplicazione dei reati e della dilatazione dell’esercizio del potere investigativo, un diritto penale totale anziché un diritto penale minimo…».
Pinelli non limita la critica all’eccesso legislativo: sposta il tema sulle conseguenze sociali e sul ruolo della pena. «Bisogna vincere l’utopia repressiva ed evitare che il carcere sia un’avanzata scuola del crimine», ammonisce, richiamando Erving Goffman e la nozione di “istituzione totale”. La sua tesi è netta: la funzione penale non può essere la risposta principale a ogni problema sociale; la politica deve esercitare scelte di depenalizzazione e investire in misure alternative.
Geografia giudiziaria, demografia e il profilo del giudice del futuro
Pinelli richiama la dimensione territoriale e demografica: la geografia giudiziaria va ripensata perché la domanda di giustizia si sposta con l’invecchiamento, i flussi migratori e la trasformazione economica. Dati proiettati (Luiss, Istat) segnalano che la composizione demografica muterà radicalmente: meno popolazione in età lavorativa, più mobilità, nuove esigenze di prossimità. La domanda: «Di che “tipo” di giudici avremo bisogno?» è al centro della riflessione.
La proposta è ambiziosa ma pragmatica: mappare i carichi, ricalibrare uffici e organici, pensare a modelli differenziati di magistrato e a forme stabili di specializzazione. È una chiamata al realismo organizzativo: non si può riformare senza dati e progetti concreti.
Tecnologia e garanzie: la sfida dell’IA
Sul versante tecnologico, Pinelli solleva interrogativi strategici: «Siamo certi che non sia necessario proiettarsi in una giurisdizione multidisciplinare dove il giudice possa essere coadiuvato dall’esperto di intelligenza artificiale?». Ma la domanda non è a favore o contro l’innovazione: è un invito a governarla. Occorre bilanciare efficienza e oralità del processo, tutelare il contraddittorio, garantire trasparenza sugli algoritmi e responsabilità umana nelle decisioni. Le tecnologie non possono diventare scorciatoie che comprimono garanzie sostanziali.
Certezza del diritto e imprevedibilità di sistema
Un altro nodo affrontato è quello della certezza del diritto: la proliferazione di fonti nazionali e sovranazionali, l’intreccio fra Corte costituzionale, Corte di Giustizia Ue e Corte Edu, producono «imprevedibilità di sistema» che indebolisce la percezione pubblica della giustizia. Pinelli sottolinea che «il principio da salvaguardare è quello della certezza del diritto, della prevedibilità della decisione e, in definitiva, di un sistema giudiziario più riconoscibile». La proposta pratica è una maggiore trasparenza motivazionale, coordinamento interpretativo e strumenti di accountability sui tempi e sugli esiti delle decisioni.
Il «tavolo giustizia 3.0»: progetto, non rituale
Il cuore propositivo dell’intervento è l’invito a un confronto strutturato: «È forse giunto il momento di aprire un “tavolo giustizia 3.0”, a cui partecipino insieme magistrati, avvocati, giuristi, accademici e politici, nel quale affrontare i problemi più pressanti che le trasformazioni epocali cui stiamo assistendo propongono alla giurisdizione, ed in cui “non si cerchi il potere (ognuno dalla propria prospettiva particolare) perché non si vuole fare il diritto” (per citare Massimo Donini)».
La concretezza è il criterio: mandati temporali, deliverable misurabili, sperimentazioni pilota, trasparenza dei risultati. Senza strumenti e budget il tavolo rischia di restare una dichiarazione retorica.
Avvocatura, etica e funzione sociale della giustizia
Pinelli chiude ricordando il ruolo dell’avvocatura: «L’avvocatura continui a combattere, partecipando al dibattito pubblico, ma ricordando che il tema giustizia non deve limitarsi all’architettura costituzionale; e che occorre non smarrire lo statuto originario dell’essere avvocato: Rechtsanwalt, garante del diritto, guardiano del diritto. C’è sempre, infatti, un diritto di un cittadino da tutelare, una vita da salvaguardare, un argine da frapporre contro gli arbitri e gli abusi, il bisogno di dare una voce a chi non ha voce». È un richiamo a porre il cittadino al centro: ogni riforma va misurata sul miglioramento del servizio giustizia per gli utenti finali — tempi, effettività delle garanzie, accesso e tutela delle libertà.
Insomma, il discorso Pinelli è insieme una difesa delle garanzie costituzionali e una piattaforma di lavoro pragmatico: difendere l’autonomia, fronteggiare il gigantismo penale, ripensare la geografia giudiziaria, governare intelligenza artificiale e tecnologia, e mettere in campo un «tavolo giustizia 3.0» con compiti e risorse.
«La giustizia non può tutto, non fa miracoli» — e per questo ha bisogno di scelte politiche coraggiose e di percorsi condivisi, non di slogan – questa la sintesi -. Se politica, magistratura e avvocatura sapranno tradurre tale consapevolezza in progetti concreti, allora la riforma potrà essere davvero funzione e non mera architettura.