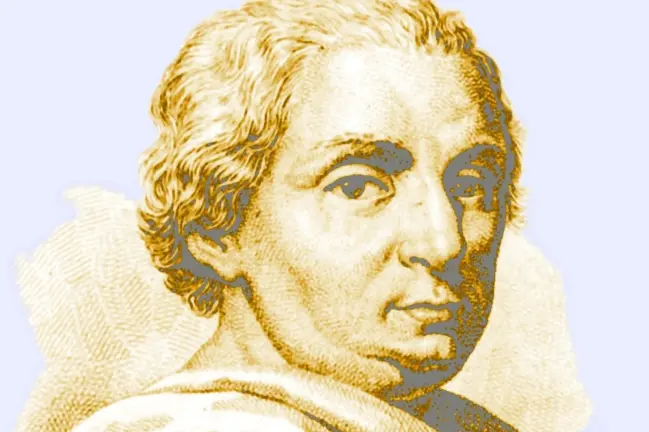PHOTO
L’ordine del mondo, per Beccaria, è retto da sistemi diversi – quello religioso e quello civile – che non debbono assolutamente intersecarsi l’un l’altro: il potere politico deve interessarsi soltanto dei reati, mai, per dir così, dell’anima del reo, territorio riservato alla religione.
Ne viene che, quando si commettono reati, per Beccaria occorrono quelli che egli definisce in modo alquanto sibillino “motivi sensibili”, capaci di distogliere dalla commissione di illeciti penali, e che altro non sono se non “le pene stabilite contro gli infrattori delle leggi”.
Beccaria spiega subito che si tratta di motivi “sensibili”, in quanto “percuotono i sensi”, vale a dire che sono percepibili in modo diretto sulla pelle di coloro che ne siano i destinatari.
Seguendo Montesquieu, la pena è legittima soltanto se assolutamente necessaria: altrimenti è tirannica. Beccaria parla ovviamente di diritto di punire da parte del Sovrano, evitando di fare un passo in più, come poi avrebbe fatto Kant, il quale teorizza invece un autentico “dovere di punire” da parte dello Stato: eppure il suo discorso avrebbe condotto di filato proprio a questo esito, vale a dire a riconoscere come il potere sovrano stesso sia al servizio delle leggi, invece che esserne padrone: e se ne è al servizio, il Sovrano non tanto ha il diritto di punire, quanto il dovere.
Ma Beccaria non giunge a tanto, preferendo invece sottolineare come le pene siano dovute per giustizia e come questa debba intendersi in senso formale e giuridico, quale il vincolo capace di tenere insieme tutti gli interessi particolari e mai in senso fattuale – quale semplice forza fisica – o in senso teologico - ove pene e ricompense sono dispensate da Dio.
Ovviamente, l’irrogazione delle pene ha delle conseguenze importanti.
La prima è quello che oggi chiamiamo il principio di legalità: le pene possono essere stabilite soltanto dalla legge, mai da altri, neppure dalla volontà del Sovrano. E’ certo difficile comprenderlo in pieno, ma affermare due secoli e mezzo fa che il Sovrano non gode del potere di stabilire le pene, doveva sembrare un atto quasi rivoluzionario.
La seconda conseguenza sta nel principio di giurisdizione e di separazione dei poteri: dal momento che il Sovrano è parte stipulante del contratto sociale, non può egli medesimo giudicare gli imputati dei reati – essendo ogni cittadino, anche imputato, l’altra parte stipulante dello stesso contratto – ma occorre un soggetto terzo ed imparziale: il magistrato.
La terza conseguenza è che le pene, per non tralignare in pure e semplici sopraffazioni, non debbono mai essere atroci, termine che Beccaria usa per significare una loro speciale carica afflittiva.
Ma il capitolo certo più interessante è quello in cui Beccaria affronta il problema della interpretazione della legge e della sua possibile oscurità.
E qui Beccaria si mostra fino in fondo figlio dell’illuminismo giuridico che egli ha tanto contribuito a diffondere e dei suoi ineliminabili limiti.
Infatti, egli propone, allo scopo di esorcizzare lo spettro della pluralità delle interpretazioni possibili della legge, che apre la porta ad ogni anarchia interpretativa, il tradizionale schema sillogistico: la premessa maggiore sta nella legge; la minore nel fatto commesso; la conclusione nella condanna o nella assoluzione.
Beccaria riprende qui la ben nota teoria di Montesquieu del giudice che si limita ad essere “bouche de la lois”, vale a dire semplice cinghia di trasmissione, del tutto neutra, di una volontà che è e rimane soltanto del Sovrano. E ciò – lo si ribadisce – per esorcizzare il pericolo delle molteplici interpretazioni a volte confliggenti.
Ma si tratta di una costruzione irreale e perniciosa, anche se ovviamente Beccaria, immerso nella cultura giuridica del suo tempo, non poteva immaginarlo.
Irreale, in quanto ogni magistrato, interpretando le formule della legge, non può certo diventare un meccanismo automatizzato, ma reca con se un tesoro di conoscenze, di esperienze, di premesse che inevitabilmente influiscono sul suo operato. Perniciosa, in quanto ignorare la realtà equivale a divenirne schiavi.
Come ha invece mostrato a sufficienza tutta la lezione ermeneutica che a partire da Gadamer – ma anche oltre Gadamer: si pensi a Pareyson, a Betti, a Mathieu – si è occupata del tema, ogni interprete muove da una pre- comprensione del testo da comprendere; e il bello è che non può evitarlo, dovendo soltanto esserne consapevole.
Il problema allora non è fare del giudice ciò che egli mai potrà essere – una sorta di macchina automatica che, sfornando sentenze, si illuda e illuda di trasmettere fedelmente la volontà del legislatore – ma far si che la necessaria pre- comprensione da cui egli muove sia trasparente, conoscibile e non frutto di follia argomentativa o conoscitiva.
Certo, non facile, ma unica strada realisticamente percorribile Quanto poi alla oscurità dei testi di legge e alla loro scarsa comprensibilità, meno male che Beccaria non può leggere le odierne leggi italiane, zeppe di errori di grammatica, di contorsionismi argomentativi, di litoti, di punteggiature approssimative: ne morrebbe di nuovo.