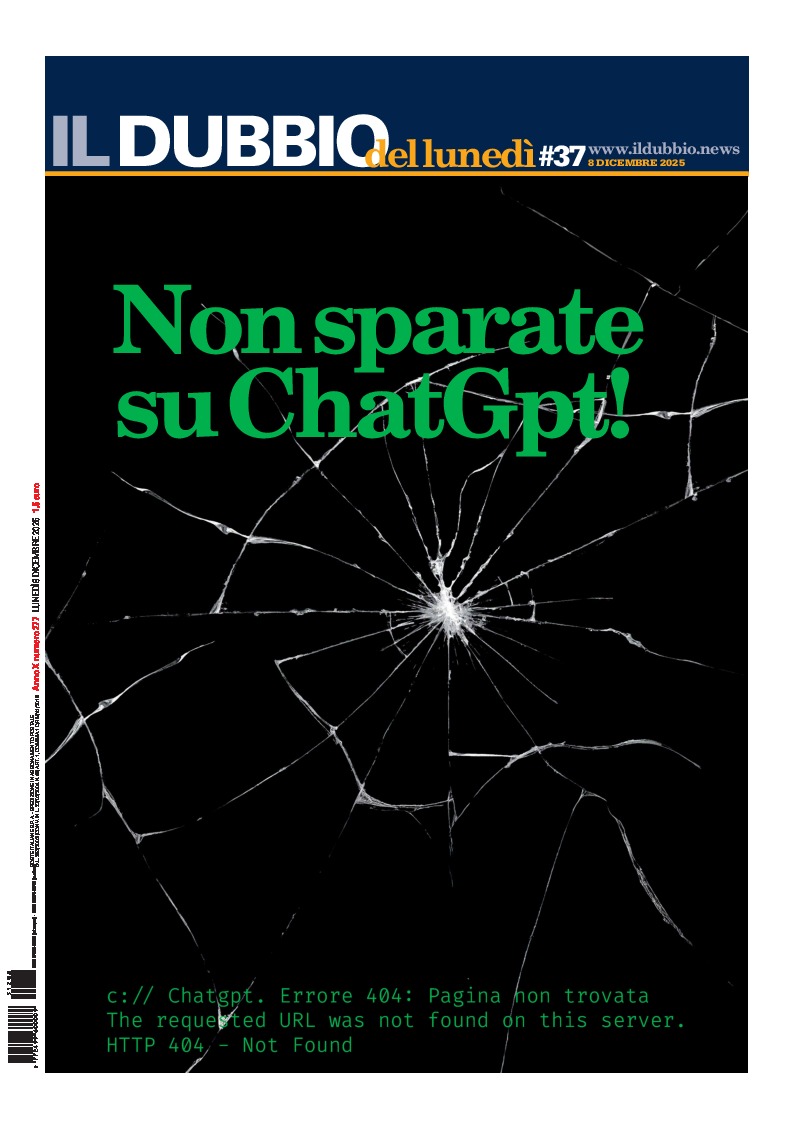PHOTO
PLENUM CSM CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA RIUNIONE
La proposta di sorteggiare i componenti del Csm, al di là del giudizio complessivo sulla riforma della giustizia proposta dal ministro Nordio, ha il merito di aver riportato l’attenzione sulle questioni istituzionali riguardanti il Csm, che sembravano archiviate dopo la riforma Cartabia.
A tal riguardo, è bene subito evidenziare che la scelta del sistema elettorale non è soltanto una questione di osservanza e coerenza con i principi costituzionali, dal momento che è necessario individuare anche le condizioni più idonee a dare attuazione a quei principi, avuto riguardo alle dinamiche su cui la normativa andrà ad incidere.
Se così è, il punto di avvio di qualsiasi riflessione sulla riforma elettorale del Csm non può non trarre l’abbrivio dallo “scandalo Palamara” e da ciò che ha significato per la magistratura, scandalo che – sia beninteso – non può essere confinato al ristretto ambito delle responsabilità di Luca Palamara, dal momento che esso, per come si evince in maniera nitida dalle migliaia di conversazioni cristallizzate nelle chat acquisite, risulta essere il portato di un sistema che ha inciso profondamente sul funzionamento del Csm, trasformandolo in un organo governato dalla lottizzazione degli incarichi, con la sistematica sostituzione del criterio del merito con quello dell’appartenenza alla corrente associativa.
In particolare, la vicenda relativa alla trattativa per la nomina del procuratore della Repubblica di Roma, nota come scandalo dell’“Hotel Champagne”, appare solo quella più eclatante e allarmante, in quanto dimostrativa dell’esistenza di un sistema di interferenze esterne all’organo consiliare, portatore di interessi opachi. Nonostante queste premesse, che hanno spinto il Capo dello Stato Mattarella a parlare di “modestia etica”, la riforma elettorale targata Cartabia, che pure sembrava voler porre fine al sistema correntocratico, non ha posto un argine alla degenerazione correntizia, se è vero che nell’attuale Csm i consiglieri, sebbene eletti formalmente al di fuori delle correnti di appartenenza, nell’esercizio del voto all’interno del Csm continuano a far riferimento, tranne rare eccezioni, agli schieramenti correntizi di appartenenza. Insomma, le correnti continuano a spirare ancora con forza!
Per converso, il sistema dell’estrazione a sorte è destinato a spezzare il legame esistente tra i componenti eletti nel Csm e le correnti associative, creando le condizioni oggettive affinché ciascun consigliere possa essere libero di valutare e decidere le pratiche consiliari, applicando i criteri previsti dalla legge, senza essere condizionato dall’appartenenza correntizia, seguendo cioè la stessa logica con cui ciascun magistrato, dotato di indipendenza, decide le cause sottoposte alla propria cognizione.
Peraltro, nessun pregiudizio subirebbe l’associazionismo giudiziario: l’Anm tornerebbe a svolgere la sua naturale funzione di tutela dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura, oltre che di controllo dell’attività del Csm, e le correnti associative ritornerebbero a essere espressione dei diversi orientamenti ideali esistenti all’interno della magistratura associata, secondo la loro originaria vocazione culturale.
In altri termini, è necessario che il Csm sia meno governato dalla politica e dalle correnti associative, che spesso strizzano l’occhiolino alla maggioranza governativa di turno, diventando inflessibili con i magistrati scomodi, non allineati e non iscritti ad alcuna corrente, che hanno il solo torto di svolgere la loro funzione in maniera indipendente, preoccupandosi solo di applicare il principio della soggezione alla legge.
Non hanno ragion d’essere, invece, le obiezioni sollevate sul sorteggio dei componenti togati del Csm, laddove evidenziano oltre misura alcune criticità, ottenebrando e obliterando con disinvoltura i mali evidenti del sistema correntizio e la perdita totale di autorevolezza e di prestigio che ne è derivata. In particolare, a coloro che si affannano a esprimere dubbi e perplessità circa il rispetto delle regole democratiche bisogna ricordare che il Csm non è un organo di rappresentanza politica, e che il sorteggio rappresenta la più antica procedura democratica, già in uso nell’Atene del V secolo a.C., e oggi diffusa nelle giurie popolari.
Quanto poi alla capacità dei sorteggiati di rappresentare degnamente il Csm, occorre rammentare che i magistrati, nello svolgimento dell’attività giudiziaria, anche in sede monocratica, possono essere chiamati ad occuparsi di vicende ben più delicate delle pratiche consiliari, vicende che spesso richiedono valutazioni estremamente complesse, e che nel Consiglio possono avvalersi di un apparato di funzionari in possesso di elevate competenze professionali.
E comunque sia, “contra factum non valet argumentum”! La risposta più adeguata alle perplessità sollevate in merito alla presunta idoneità dei sorteggiati risiede proprio nella concreta esperienza istituzionale, dal momento che il primo sorteggiato della storia consiliare, il consigliere Andrea Mirenda, ha dimostrato che qualunque magistrato indipendente e autonomo è in grado di affrontare degnamente e fattivamente l’impegno consiliare anche se privo di copertura correntizia.
In conclusione, ritengo che il sorteggio, pur con i limiti propri di ogni sistema elettorale, non vada giudicato con un atteggiamento preconcetto, e, anzi, debba essere considerato con favore, essendo oggi l’unico rimedio in grado di stroncare in radice il sistema correntocratico e di restituire credibilità all’autogoverno della magistratura.