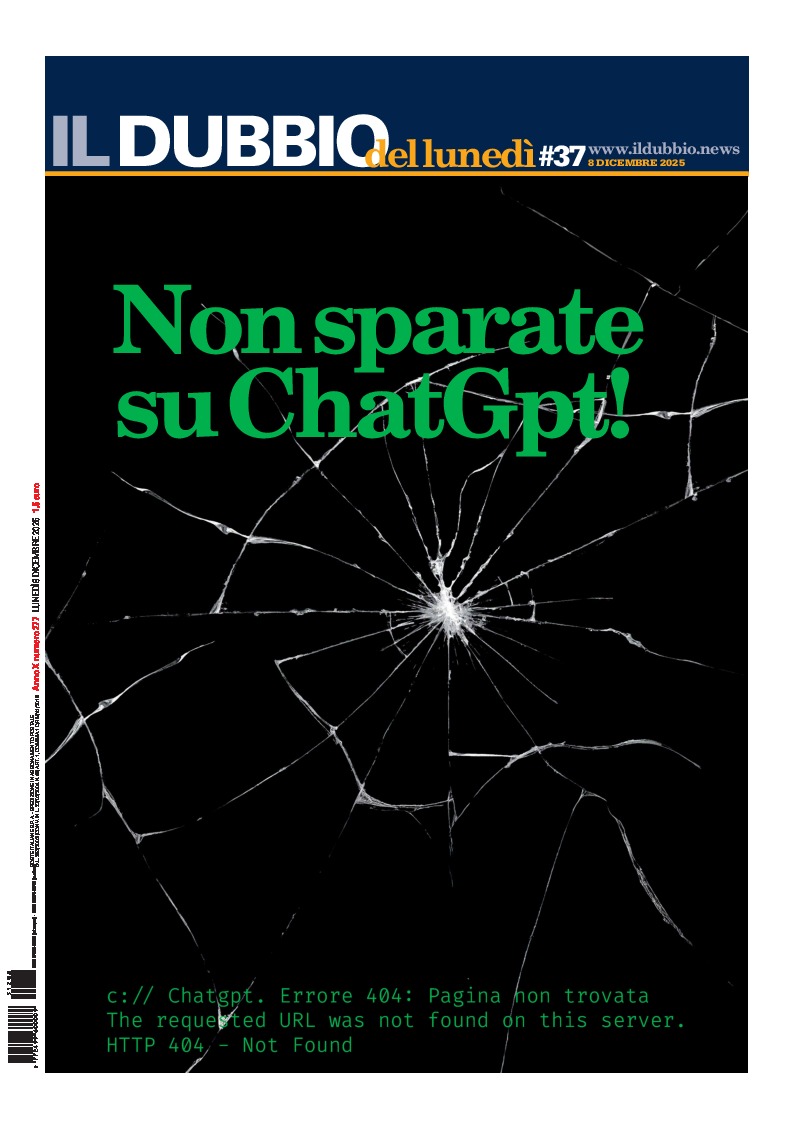PHOTO
Mario Follieri, nel corso della VI Legislatura (1975), quale Senatore della Repubblica, svolse le funzioni di Relatore della legge sull’Ordinamento giudiziario, battendosi per l’affermazione del diritto alla sessualità dei detenuti ( art. 15).
La proposta, proprio a seguito dell’impegno di diversi senatori, fu approvata a Palazzo Madama e poi respinta alla Camera. La tesi di fondo sostenuta era quella che lo Stato, per essere autorevole e rispettato, dovesse dimostrarsi giusto prima di tutto nei confronti dei deboli e, quindi, dei detenuti. Aggiungasi un altro aspetto che fu evidenziato: il fenomeno della cosiddetta “omosessualità temporanea o indotta”.
Questo essere omosessuali non è una scelta consapevole, appare di contro un effetto dell’adattamento al contesto carcerario. Questo pregiudica, destrutturandola, l’identità individuale e sociale del soggetto rappresentando uno degli aspetti più problematici della reclusione, durante la quale si possono sviluppare le “anormalità” sessuali e la conseguente sofferenza nell’individuo.
Il problema della sessualità in carcere ha trovato oggi una adeguata soluzione grazie alla Corte Costituzionale (10/ 2024) e alla Cassazione( 8/ 2024), che hanno riconosciuto il diritto all’affettività e alla sessualità dei detenuti.
La Corte costituzionale ha tutelato il diritto all’affettività in carcere, dichiarando che la detenzione non può annullare i diritti fondamentali della persona. Consegue, pertanto, la dichiarata illegittimità costituzionale dell’articolo 18 dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevedeva che la persona detenuta potesse essere ammessa a svolgere i colloqui, anche affettivi, con il coniuge o la persona con lei stabilmente convivente, quando non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina.
La Cassazione, a sua volta, riaffermava la portata dei principi affermati dalla Consulta. Nella sentenza si ribadisce che la richiesta di poter svolgere colloqui con la propria moglie in condizioni di intimità debba essere effettivamente realizzata, essendo stato affermato che tali incontri costituiscono una legittima espressione del diritto all’affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari, e possono essere negati solo per «ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina».
In questo contesto nascono le Linee guida del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP) e le nuove regole per i colloqui intimi, stabilendo che possono essere concessi, nel numero di quelli visivi (mensili), con una durata massima di due ore e con la chiusura della porta. Ricordiamo che il carcere prospetta per il condannato l’obbligo di espiare la sanzione inflittagli, ma nello stesso tempo pone a carico dello Stato la responsabilità, impostagli dalla Costituzione: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” ( art. 27Cost.).
Le vicende successive all’inizio dell’espiazione diventano, pertanto, un affare dell’Autorità preposta, tenuta a curarsene a norma dei principi dell’Ordinamento penitenziario.
Peraltro, il ricordo dell’On. Follieri mostra come già nella metà degli anni Settanta cominciasse a farsi strada il principio che l’espiazione della pena non è tanto né solo un’afflizione, una limitazione della libertà, con tutte le conseguenze che da ciò derivano, ma è soprattutto la possibilità per il condannato di emendarsi, di migliorare le sue qualità, la sua intelligenza, la sua coscienza, per essere rimesso nel circuito sociale.
In definitiva, possiamo ritenere che la rieducazione possa attuarsi attraverso i seguenti percorsi: lavoro, istruzione, libero culto di ogni religione e contiguità con la realtà, nonché vicinanza al nucleo familiare. E se si sostiene che vanno rispettati non solo i diritti umani del detenuto, ma anche i suoi bisogni umani, tra questi certamente è possibile far rientrare la sessualità.
Le Linee guida del DAP fissano ora una disciplina volta a stabilire termini e modalità di esplicazione del diritto all’affettività, individuando i destinatari, interni ed esterni, per la concessione di colloqui intimi, fissando il loro numero, la loro durata, la loro frequenza, con la conseguente determinazione delle misure organizzative interne. Dai dati aggiornati al dicembre 2024, la platea di potenziali beneficiari è di circa 17mila detenuti su oltre 61 mila detenuti.
Attualmente, nonostante i progressi, permangono difficoltà nell’attuazione di questo diritto, a causa della mancanza di spazi dedicati, e delle valutazioni discrezionali delle direzioni penitenziarie. In sintesi, mentre il diritto all’affettività e alla sessualità in carcere è stato riconosciuto, la sua reale attuazione presenta ancora delle necessità di ulteriori interventi normativi e strutturali. Numerose sono state le proposte di legge in materia di affettività e sessualità, calendarizzate per la discussione, ma mai discusse. Questo suscita critiche, imbarazzi, polemiche, oltre che perplessità. La sessualità costituisce l’unico aspetto della vita di relazione dei detenuti a non essere normativizzato, quasi che la privazione sessuale, come in passato, debba necessariamente continuare ad accompagnare lo stato di detenuto.