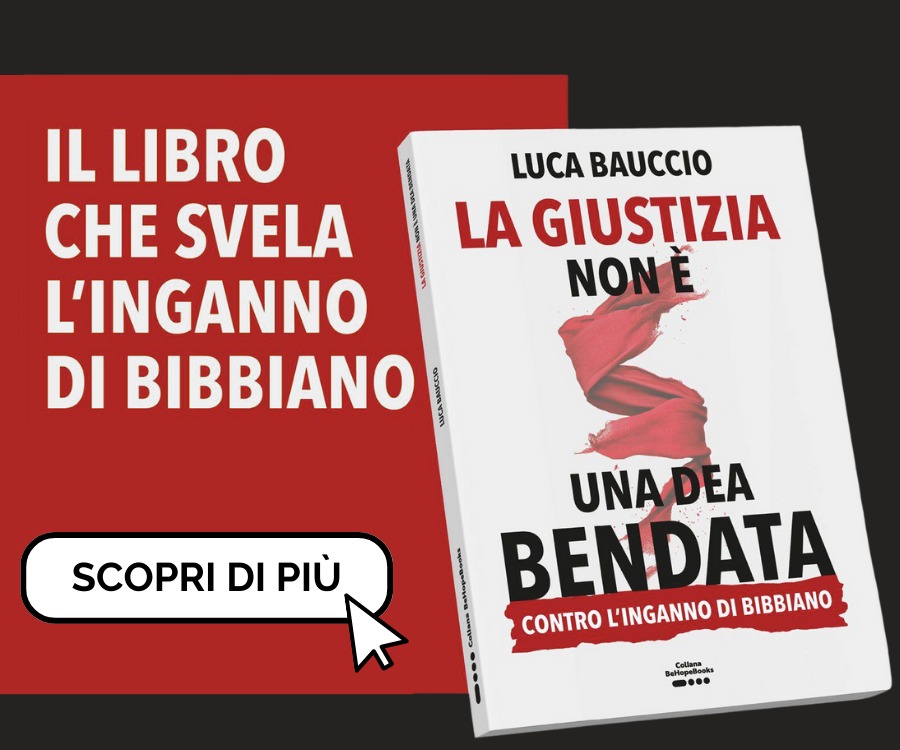PHOTO
Pd Letta Draghi
La discussione di queste ore, in Aula e fuori, sulla riforma del Csm, sta mettendo in luce le molte contraddizioni della maggioranza che sostiene il governo Draghi, ma una su tutte: dopo oltre un anno dalla sua nascita e a meno di dodici mesi dalle prossime Politiche, dovremmo cominciare a chiamarlo governo PDraghi. Sì perché se guardiamo al dibattito politico delle ultime settimane, chi più chi meno tutti i partiti che appoggiano l’esecutivo dell’ex presidente della Banca centrale europea hanno cercato di emanciparsi dall’abbraccio di Super Mario. Tutti, tranne il Pd.
Lo ha fatto il Movimento 5 Stelle, con il tira e molla sulla possibilità di fornire armi a Kiev, prima, e sull’utilità di aumentare le spese militari fino al 2 per cento del Pil, dopo. Con tanto di richiesta di incontro sia al presidente del Consiglio (e conseguente nota stizzita di palazzo Chigi), sia al capo dello Stato, Sergio Mattarella, maestro nel ricucire ago e filo rapporti ormai logori.
E lo ha fatto, forse con ancor più clamore, il centrodestra di governo, questa volta sull’eterna questione della riforma del catasto. Prima chiedendone a gran voce lo stralcio, pena la crisi di governo perché «la casa è sacra» (copyright Matteo Salvini), poi formulando alcune proposte di modifica presentate allo stesso Draghi nel corso dell’ennesimo faccia a faccia per «chiarire le proprie posizioni» (cit. Antonio Tajani). Con tanto di dichiarazioni alla stampa sotto il sole di Roma per dirsi «soddisfatti di non avere ottenuto quello che avevano chiesto» (questa è di Elio Vito, deputato di Forza Italia considerato ormai un eretico). Ovviamente, al valzer del “resto, ma…” non poteva mancare Italia Viva, che proprio sulla riforma della giustizia ha deciso per il più pilatesco dei voti: l’astensione. Se n’è lavata le mani, perché «questa riforma non è dannosa come quella di Bonafede ma è semplicemente inutile», dal vangelo secondo Matteo (Renzi).
A dire la verità, in tema di politica economica qualche timida voce dal Nazareno si è pure alzata, nel tentativo di chiedere uno scostamento di bilancio del quale però a palazzo Chigi non vogliono nemmeno sentir parlare. Così come si è alzato un coro dai sindaci dem, nell’ordine Beppe Sala, Dario Nardella e Matteo Ricci, per chiedere al governo più fondi agli enti locali, battaglia sulla quale i primi cittadini non sembrano però sostenuti granché dal proprio apparato dirigente di partito.
Ecco dunque che si arriva al dibattito di queste ore, su una riforma della giustizia partita con l’intento di mettere fine alla guerra dei Trent’anni tra magistratura e politica iniziata il 17 febbraio 1992 con l’arresto di Mario Chiesa, e tuttora in corso. Ma più il traguardo si avvicina (già domani si potrebbe arrivare al voto finale), e più questa riforma perde vigore, un po’ come quei ciclisti che certi della vittoria alzano le braccia al cielo pochi metri prima della linea d’arrivo, rischiando la brutta figura d’essere sorpassati sul finale dagli inseguitori. Rischio che questo governo non correrà a livello di numeri, nonostante la decisione di non mettere la fiducia, ma che rende politicamente evidente come dei tanti gregari che lo scalatore Draghi aveva al via, sia rimasto fedele il solo Pd.
Restando in tema di metafore su due ruote, la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti dem, Anna Rossomando ha detto ieri che «sulla riforma del Csm, finito il tratto in salita, si inizia a vedere la pianura nel percorso verso l’approvazione», seminando ottimismo. «È un testo che non si limita alla modifica della legge elettorale, perché ovviamente questa da sola non può bastare per affrontare il tema centrale, il contrasto degli accordi di potere - ha sottolineato la senatrice - Ecco perché ci siamo battuti e siamo arrivati alla definizione di norme come lo stop alle nomine a pacchetto, la separazione tra disciplinare e nomine e il voto degli avvocati nei consigli giudiziari, che rappresentano punti concreti nel contrasto agli accordi di potere».
A proposito di accordi di potere, sembra evidente come l’avvicinarsi dalla fine della legislatura ponga i partiti di fronte a un bivio: sostenere in tutto e per tutto, fino alla fine, il governo di cui fanno parte; distaccarsi piano piano, magari senza darlo troppo a vedere, così da arrivare alle prossime Politiche nella giusta posizione, pronti a darsi battaglia all’ultimo voto. Di fronte a questo scenario, soltanto il Pd di Enrico Letta sembra optare per la prima scelta. Tutti gli altri stanno già facendo a spallate. Anche perché tutti, Pd compreso, dovranno prima o poi fare i conti con la realtà dei fatti: cioè che in questa pazza corsa che durerà per i prossimi dodici mesi, chi parte in testa, almeno stando al consenso registrato dai sondaggi, è l’unico partito strutturato che siede all’opposizione.