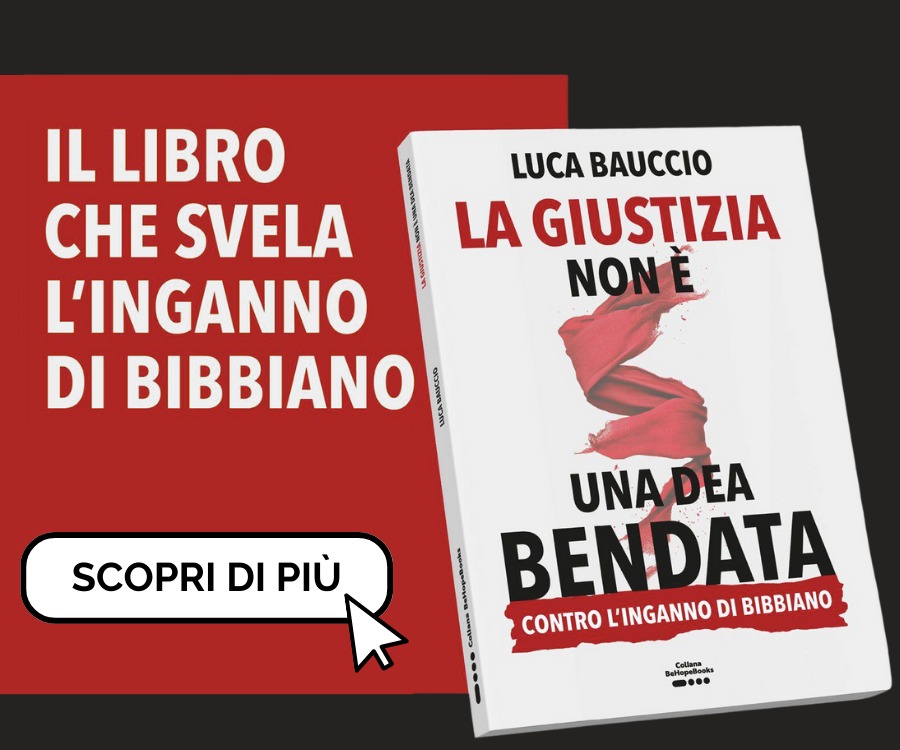PHOTO
renzi letta
Che Enrico Letta, tornato da Parigi dove si era ritirato a causa di Matteo Renzi, non avesse dimenticato per niente il torto subito sette anni prima col sostanziale licenziamento da presidente del Consiglio e avesse ben poca voglia di riannodare da segretario del Pd i rapporti con lui, si era capito subito. E se ne era avuta la prova dal calendario degli incontri obbligati del successore di Nicola Zingaretti al Nazareno con gli interlocutori della maggioranza di governo.
Renzi era finito all’ultimo posto: proprio l’ultimo, ben dopo Giuseppe Conte fresco di mezza designazione verbale, o intimistica, a presidente del MoVimento 5 Stelle, e ancora orgoglioso della qualifica di “punto di riferimento dei progressisti” conferitagli dal predecessore di Enrico Letta, cioè Nicola Zingaretti, quando il professore e avvocato pugliese sembrava ben saldo a Palazzo Chigi. Pareva addirittura in grado di sottrarsi alle minacce di crisi da parte di Renzi - sempre lui - tessendo la tela di un suo terzo governo in tre anni.
Per fortuna, d’altronde, lo stesso Renzi aveva dato ad Enrico Letta ragioni e occasioni di un rapporto a distanza lasciando il Pd, nella tarda estate del 2019, ben prima quindi che Nicola Zingaretti si stufasse della sua esperienza al Nazareno e addirittura ne fuggisse via denunciando il clima avvelenato che vi si respirava. Renzi si era messo in proprio con un partito piccolo ma numericamente decisivo in Senato per tenere in piedi, o appeso, il secondo governo Conte. Un partito piccolo, dicevo, ma quasi dichiaratamente corsaro, trattenuto a stento, o costretto a rallentare le sue incursioni, quando la sopraggiunta pandemia in qualche modo aveva avvolto l’allora presidente del Consiglio in un involucro di emergenza, straordinarietà e quant’altro. Ma figuriamoci se Renzi, con quel temperamento che ha, poteva trattenersi più di tanto. Proprio la pandemia, con l’obiettiva e crescente difficoltà di gestirla, gli avrebbe poi dato motivi e occasioni per disarcionare Conte e fare arrivare a Palazzo Chigi un fuoriclasse come Mario Draghi: tanto fuoriclasse che Enrico Letta lo vorrebbe a quel posto “almeno” fino alla conclusione ordinaria della legislatura, nel 2023. Ciò significa anche dopo, se le circostanze potranno permetterlo, visto che il piano della ripresa varato con i finanziamenti miliardari dell’Unione Europea, e condizionato ad un percorso di riforme, dovrà arrivare alla scadenza del 2026.
Costretto dagli umori, a dir poco, dei gruppi parlamentari, di cui è riuscito a cambiare i presidenti ma non certo la composizione, rimasta quella derivata dalle candidature volute nel 2018 dall’allora segretario del partito Renzi, sempre lui, Enrico Letta ha dichiaratamente lavorato sino all’altro ieri, diciamo così, per la costruzione di un centrosinistra “largo”, tradotto da qualcuno in una nuova edizione dell’Ulivo, esteso da Renzi a Bersani, un altro ex segretario del Pd andatosene dal Nazareno. E vi ha lavorato ignorando, o facendo finta di ignorare, la preclusione a Renzi, e anche a Carlo Calenda, dichiarata da Conte. Che non è più quello immaginato da Nicola Zingaretti alla testa di uno schieramento progressista, è formalmente alla guida di un movimento malmesso elettoralmente e in crisi ormai cronica di identità, ma rimane pur sempre la seconda forza della coalizione coltivata dal segretario del Pd.
Forse già rassegnato in cuor suo a sorbirsi Renzi, oltre a Calenda, perché consapevole di avere in fondo un potere contrattuale inferiore a quello sbandierato in pubblico, e cui in fondo non credono molto neppure molti grillini, Conte si è visto quasi sorpassare nell’antirenzismo da Enrico Letta dopo l’infortunio del segretario del Pd al Senato nello scontro col centrodestra sul disegno di legge del piddino Alessandro Zan contro l’omotransfobia, già approvato dalla Camera. Con Renzi mai più, ha praticamente gridato e giurato Enrico Letta attribuendogli, dietro la cortina di una corsa in Arabia Saudita solitamente ben retribuita, la regia dello stop imposto al provvedimento a scrutinio segreto. E di chissà quali altri giochi, a cominciare dalla sempre più vicina e ingarbugliata partita del Quirinale.
Renzi, dal canto suo, non si è lasciato scappare l’occasione per fare a Letta, stavolta in pubblico, un mezzo processo politico come quello del 2013 parlando al telefono col generale della Guardia di Finanza Michele Adinolfi, che non sapeva di essere intercettato per un’indagine. In quell’occasione Renzi disse di Letta presidente del Consiglio che non era adatto a stare al suo posto, dove infatti lui lo avrebbe di lì a poco sostituito: magari, sarebbe stato più indicato per il Quirinale, aggiunse sapendo bene che vi sedeva allora del tutto tranquillo Giorgio Napolitano, confermato da alcuni mesi soltanto, e che Letta non aveva neppure l’età per aspirarvi a breve, avendo ancora 47 anni, contro i 50 richiesti dalla Costituzione.
Alto e forte, tuttavia, si è levato dal Pd il monito di un uomo non sospettabile di collusione con Renzi: l’ex capogruppo al Senato Luigi Zanda. Secondo il quale «non è dall’esito di uno scrutinio segreto certamente grave sul ddl Zan che il Pd deve elaborare la sua politica delle alleanze». Non è così che deve essere definito «il perimetro del centrosinistra», anche perché ci si «dovrebbe rassegnare a restare in minoranza nell’aula del Senato da qui fino alla fine della legislatura». A meno che Enrico Letta non stia maturando sotto sotto un progetto di elezioni anticipate. Ma questo Zanda non lo ha sospettato, o, almeno, non lo ha detto.