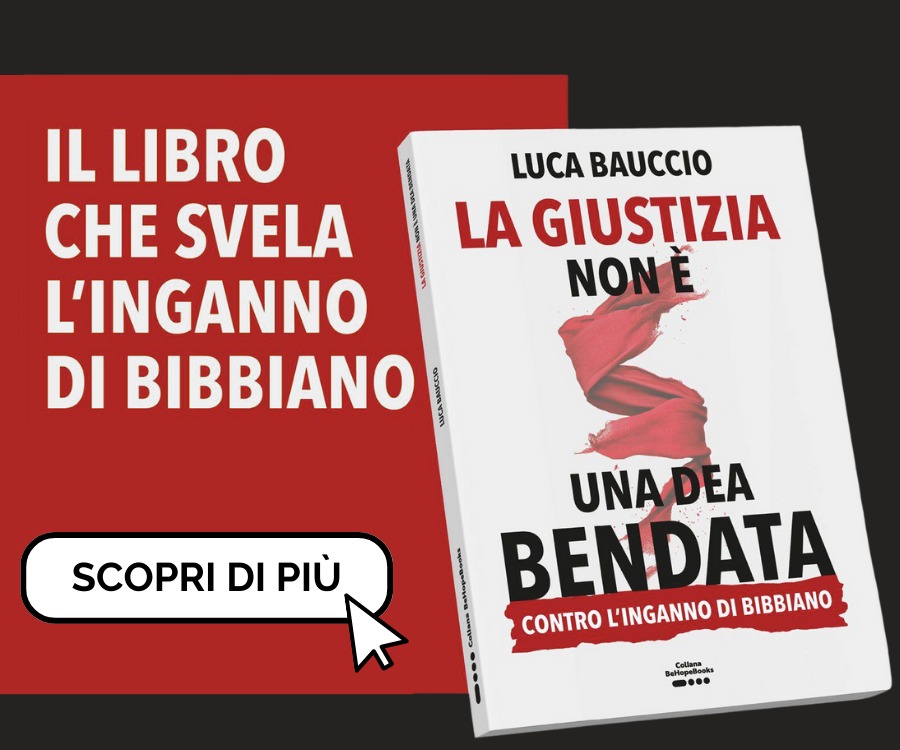PHOTO
Una delle questioni che, di frequente, si pongono nel nostro sistema produttivo, e su cui si sono scritte pagine di dottrina e giurisprudenza, riguarda la qualificazione e, dunque, la "remunerabilità" del cosiddetto tempo di reperibilità. E cioè di quella parte del proprio tempo in cui il lavoratore, pur non svolgendo alcuna attività lavorativa, è comunque a disposizione del datore di lavoro per far fronte ad eventuali esigenze variabili ed imprevedibili. Storicamente si è molto dibattuto se questo tempo che di fatto si pone in una "zona grigia" - anticipando la prestazione che resta meramente eventuale e non richiede di fatto alcuna attività - debba essere considerato di per sé "tempo di lavoro" o "tempo di riposo". Infatti, si tratta di una prestazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella tipicamente di lavoro, che consiste nel solo obbligo del lavoratore di essere prontamente rintracciato e a cui spesso corrisponde uno specifico compenso aggiuntivo alla normale retribuzione corrisposta nel caso in cui la prestazione venga poi effettivamente resa. Non è un tema in assoluto nuovo in quanto, per esempio, la questione si era già posta negli anni Novanta, con riferimento al cosiddetto "tempo tuta". Al riguardo, la giurisprudenza si era interrogata a lungo se fosse da considerare tempo di "lavoro" quello necessario ad indossare abiti e attrezzature funzionali allo svolgimento della prestazione, spesso seguendo procedure unilateralmente fissate dal datore. Alla fine, si ricorderà che la questione era stata risolta dalla Cassazione nel senso di escludere la remunerabilità di questo tempo. Direttamente sul tema della reperibilità la Corte di Giustizia Ue a sua volta si era già espressa a proposito di un lavoratore addetto al servizio di guardia (C-518/15 caso Matzak), ritenendo che il tempo di reperibilità debba essere incluso nell’orario di lavoro nel caso in cui il dipendente non soltanto sia tenuto a essere raggiungibile durante i servizi di guardia, ma debba essere pure fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro (nella specie, il privato domicilio) e rispondere alle sue convocazioni entro 8 minuti. Stavolta la Corte europea, pronunciandosi sul caso di un tecnico per le trasmissioni che operava in una zona montuosa in Slovenia e di un pompiere tedesco che, in reperibilità, doveva poter raggiungere i confini della città in venti minuti con tenuta e veicolo di servizio, ha chiarito che quello di reperibilità può essere considerato "tempo di lavoro" solo quando vengano posti al lavoratore, dalla contrattazione collettiva e/o individuale, significativi vincoli che, in modo oggettivo e concreto, condizionino pesantemente la sua vita personale nel tempo di attesa dell’ipotetica chiamata in servizio. Invece – ha scritto nero su bianco la Corte - "non sono rilevanti" difficoltà organizzative che conseguano al lavoratore per effetto di "fattori naturali o della sua libera scelta". In altri termini, i giudici comunitari si sono preoccupati di determinare le condizioni tipologiche a fronte delle quali il tempo occorrente al lavoratore per raggiungere il posto di lavoro possa o meno rientrare nel concetto di orario di lavoro e quindi essere retribuito. La Corte al riguardo ha però evidenziato che spetta poi ai giudici nazionali il compito di valutare caso per caso le circostanze in cui tale principio possa trovare di fatto applicazione, tenendo conto in maniera concreta non solo degli altri vincoli che sono imposti al lavoratore e che comunque incidono sul periodo di prontezza, quali ad esempio quello di essere munito di un determinato equipaggiamento o della frequenza media degli interventi. Insomma, un altro passo avanti della giurisprudenza nella direzione di favorire un bilanciamento tra vita di relazione del lavoratore dipendente e esigenze aziendali. *Prof. Avv. Severino Nappi, avvocato giuslavorista e professore di Diritto del Lavoro all’Università di Napoli