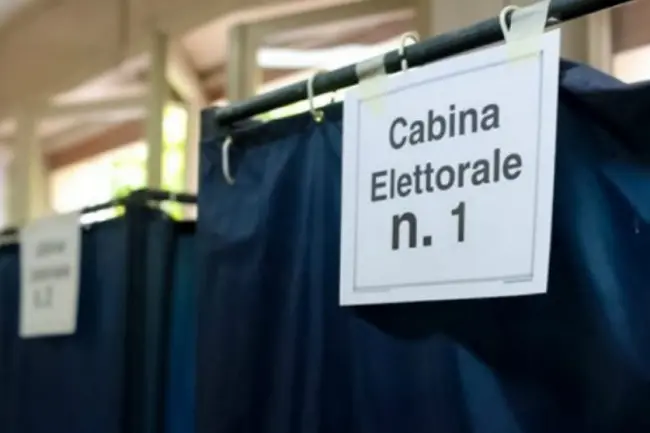PHOTO
Ci sono oggi in Italia tre leader la cui posizione traballa, uno dei quali, anzi, in apparenza è già stato sbalzato di sella. Tutti e tre aspettano con comprensibile ansia il voto di oggi e domani, dal quale potrebbe in buona parte dipendere il loro futuro.
Luigi Di Maio, ex "capo politico" dei 5S sulla carta è già un ex. Però non è stato sostituto, farlo sembra impresa per i pentastellati impossibile e finché la poltrona resta vacante rimane in prima fila al posto di comando. Una sua riconferma, se e quando i 5S si decideranno a svolgere i loro chimerici "stati generali", è più o meno fuori discussione.
Però se il Movimento deciderà di non decidere, affidando il timone a un mucchio di 5 o 7 rappresentanti delle varie anime dei 5S, continuerà ad avere più voce in capitolo di chiunque altro.
Dal referendum Di Maio si aspetta una spinta vigorosa, il rilancio di un Movimento in crisi permanente, che perde parlamentari a voti in un'emorragia interminabile. La sconfitta del Sì sarebbe una pietra tombale, ma non solo per lui. Il declino diventerebbe irreversibile per l'intera creatura di Grillo e di Gianroberto Casaleggio. Ma non si vive di solo referendum. I voti di lista saranno un indicatore più preciso e più importante.
L'arrembaggio del Pd per chiudere un accordo permanente e ovunque scatterà presto, Di Battista affila le armi per riportare il Movimento alle bandiere delle origini, sotto la sua guida ( ma non necessariamente mettendo da parte il "gemello diverso" Giggino). Salvo esiziale sconfitta referendaria, la partita di Di Maio sarà lunga e l'esito delle regionali rappresenterà solo un elemento tra gli altri, pur se non trascurabile. Anche per lui, però, la fase che inizierà subito dopo la chiusura delle urne avrà in gioco l'intera posta. Potrebbe uscirne di nuovo leader (o co- leader) di fatto di un Movimento indebolito ma ancora vivo. Potrebbe anche imboccare il viale del tramonto, in celere discesa.
Per gli altri due leader claudicanti, invece, le urne saranno una giuria e il verdetto potrebbe rivelarsi senza appello. Dal Papeete in poi Salvini non ne ha azzeccata una. La Lega resta il primo partito, ma in calo progressivo e rapido. Il voto dirà se la tendenza è irrefrenabile o già arrestata. Dipenderà solo in parte dalla Toscana, anche se conquistare la regione rossa metterebbe comunque il leader al riparo da ogni agguato. Perdere la Toscana non sarebbe certo esiziale per Salvini ma se alla lista si aggiungesse anche la Puglia la mazzata sarebbe ferale. In questo caso però molto dipenderà non tanto dal voto di lista, comunque utile per certificare il successo o il fallimento della strategia salviniana di sfondamento al sud, quanto dallo scarto tra i voti che prenderà Zaia in Veneto e quelli andranno alla lista leghista. Se la forbice sarà molto larga il messaggio diventerà inequivocabile e l'eventualità di una sostituzione a breve della leader leghista con qualcuno che sia espressione del "partito del nord", quello da un lato più legato alla vecchia Lega bossiana ma dall'altro più governista, meno tribunizio e soprattutto più accettabile a Bruxelles, diventerebbe concreta. Non subito, certo ma, anche considerando i molti guai giudiziari di Salvini, neppure in tempi biblici.
La posizione di Nicola Zingaretti è anche più instabile. La vittoria del No, che per il Pd sarebbe un danno limitato e forse a conti fatti un vantaggio, l travolgerebbe. È una eventualità improbabile ma le Regioni sono più minacciose. La sconfitta in Toscana lo trasformerebbe in un ex segretario ma anche dalla sconfitta in Puglia uscirebbe ammaccato. A quel punto tutto dipenderebbe dl voto di lista: sopra il 22 per cento Zingaretti sarebbe almeno per il momento al sicuro, sotto il 20 per cento neppure la tenuta in Toscana basterebbe.
A quel punto, inevitabilmente, si aprirebbe la sfida per la segreteria, anche in questo caso con tempi non immediati ma neppure lunghi e il quadro politico, al momento, permette di intravedere un solo possibile concorrente, però molto forte: Stefano Bonaccini che ha già impostato una campagna basata sul recupero di quello che era il massimo dogma per il Pci, ripreso dai partiti eredi, poi abbandonato da Renzi e non recuperato, più per incapacità che per mancanza di volontà da Zingaretti: l'unità a tutti i costi. Chiedere il rientro di tutti, da Bersani a Renzi significa brandire quella bandiera. Che la base, nella stragrande maggioranza, continua a rimpiangere.