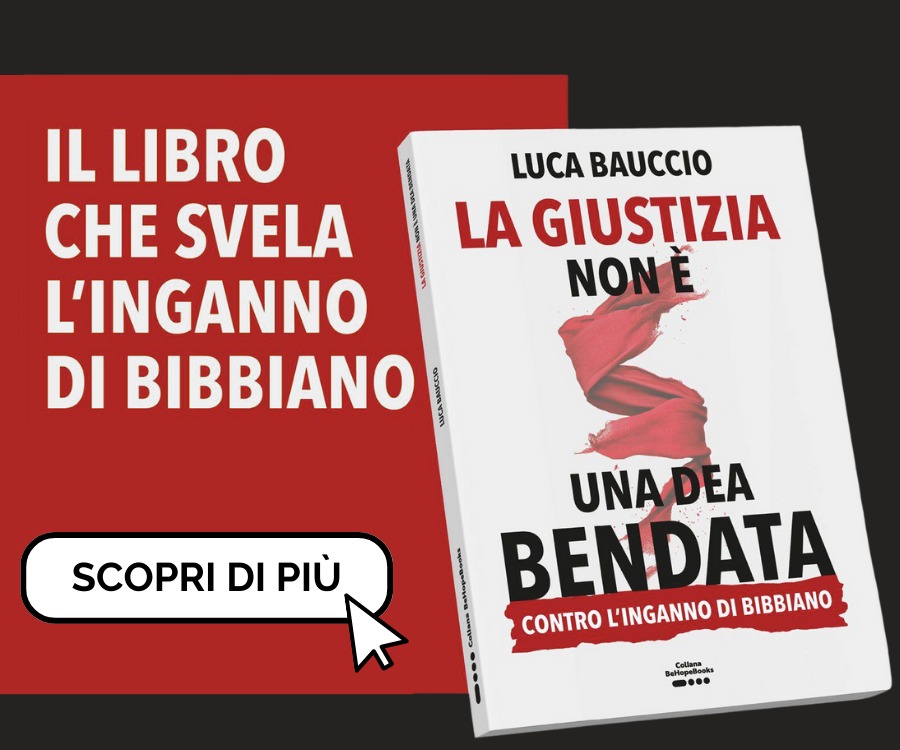PHOTO
bonafede conte
Ciclicamente torna al centro del dibattito, insieme alla furia delle posizioni opposte e contrarie. Il governo Conte ha annunciato di voler mettere mano al reato di abuso d’ufficio: per definire in maniera «più compiuta» la condotta rilevante, ha spiegato il premier. La notizia ha suscitato un coro di indignazione. Da destra, con Matteo Salvini in testa, si chiede l’abolizione in toto «di un reato “fantasma” che blocca la Pubblica Amministrazione e rallenta tutto». Al governo, invece, l’imbarazzo cresce nei 5 Stelle: nati come sostenitori dell’inasprimento delle pene ( da deputati, il ministro Alfonso Bonafede e il suo sottosegretario Valerio Ferraresi avevano presentato un disegno di legge per portare la pena da 4 a 5 anni, in modo da permettere l’uso di intercettazioni come mezzo di ricerca della prova), oggi dovrebbero sottoscrivere una parziale riscrittura dell’articolo. Una riscrittura che per giunta potrebbe cancellare con un colpo di spugna i processi contro le sindache pentastellate Chiara Appendino e Virginia Raggi, accusa Forza Italia.
In ogni caso, da qualsiasi fronte politico lo si guardi, il reato è la bestia nera di sindaci e amministratori: oltre alle prime cittadine di Torino e Roma, l’abuso d’ufficio è stato contestato anche al milanese Beppe Sala e ai due governatori di Puglia e Campania, Michele Emiliano e Vincenzo De Luca. Oggi, la nuova formulazione in discussione nella bozza del dl Semplificazioni attribuisce «rilevanza», oltre che alla violazione da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio delle regole di condotta previste dalla legge, anche «alla circostanza che da tali specifiche regole non residuino margini di discrezionalità per il soggetto», modificando così l’attuale previsione che si riferisce genericamente alla violazione di norme di legge o di regolamento. L’ennesimo ritocco a una fattispecie che negli ultimi trent’anni è stata oggetto di rimaneggiamenti più o meno profondi ma che dagli anni Novanta instilla - per dirla con Conte - la «paura della firma» a tutti gli anelli di comando della Pa.
Nel vecchio codice Rocco si chiamava “abuso innominato”, era rubricato all’articolo 323 del codice penale e puniva “il pubblico ufficiale il quale, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni”, avesse commesso qualsiasi fatto non preveduto dalla legge come reato da una particolare disposizione, “per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio”. Sostanzialmente, una norma penale in bianco, con una fattispecie vaga ma una pena definita. Poi arrivarono gli anni Novanta e l’allora ministro della Giustizia del governo De Mita, Giuliano Vassalli, oltre alla riforma del codice di procedura penale, avvia e porta all’approvazione anche la legge 86 del 1990, che modifica profondamente i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione. Così l’abuso innominato diventa abuso d’ufficio e si trasforma in una delle figure cardine del sistema dei delitti contro la Pa. L’articolo 323 viene di fatto riscritto e allargato dal punto di vista soggettivo, pur nel tentativo di circoscrivere la vastità della fattispecie precedente: incriminava, salvo che il fatto costituisse più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, avesse abusato del suo ufficio, con la circostanza aggravante nel caso in cui il vantaggio avesse avuto carattere patrimoniale. La nuova formulazione che inglobava le fattispecie di interesse privato e peculato per distrazione ( abrogate come autonomi titoli di reato) - si sforzava di descrivere in modo preciso il fatto punibile proprio per evitare che la genericità della norma permettesse una eccessiva discrezionalità da parte della magistratura.
Risultato non raggiunto, però, perchè la prassi giurisprudenziale dilatò la fattispecie, provocando proprio ciò che si voleva evitare: lo sconfinamento del pubblico ministero in settori riservati alla discrezionalità della Pubblica amministrazione.
Per provare ad arginare il fenomeno, passato il tornado di Mani Pulite, il governo Prodi I approvò nel 1997 la riforma che restringeva il campo di intervento, introducendo da un lato la clausola «salvo che il fatto non costituisca più grave reato» ( così da tentare di rendere l’abuso d’ufficio ai reati di corruzione o concussione), dall’altro inserendo alcuni precisi elementi costitutivi del reato: lo svolgimento delle funzioni; la violazione di norme di legge o di regolamento; la limitazione al dolo intenzionale e il danno o vantaggio patrimoniale ingiusto come conseguenza della condotta (la cosiddetta doppia ingiustizia: condotta ingiusta e guadagno ingiusto).
Nemmeno questo, tuttavia, ha nei fatti modificato l’attitudine allo “stiracchiamento” estensivo di una fattispecie capestro delle condotte più diverse.
Ultimo in ordine di tempo a intervenire sul testo con un minimo ritocco è stato il governo Monti, che ha disposto nel 2012 l’inasprimento della pena, che da da sei mesi a tre anni diventa da uno a quattro.
Ora è il momento del governo Conte di tentare l’introduzione di limiti, tutti giocati in punta di lessico: difficili da approvare, oltre che aleatori.
Del resto, maggioranze ben più coese della sua hanno tentato l’impresa di accorciare i tentacoli di un reato piovra con la fama di grimaldello giudiziario che destabilizza la politica. Ma con risultati non entusiasmanti.