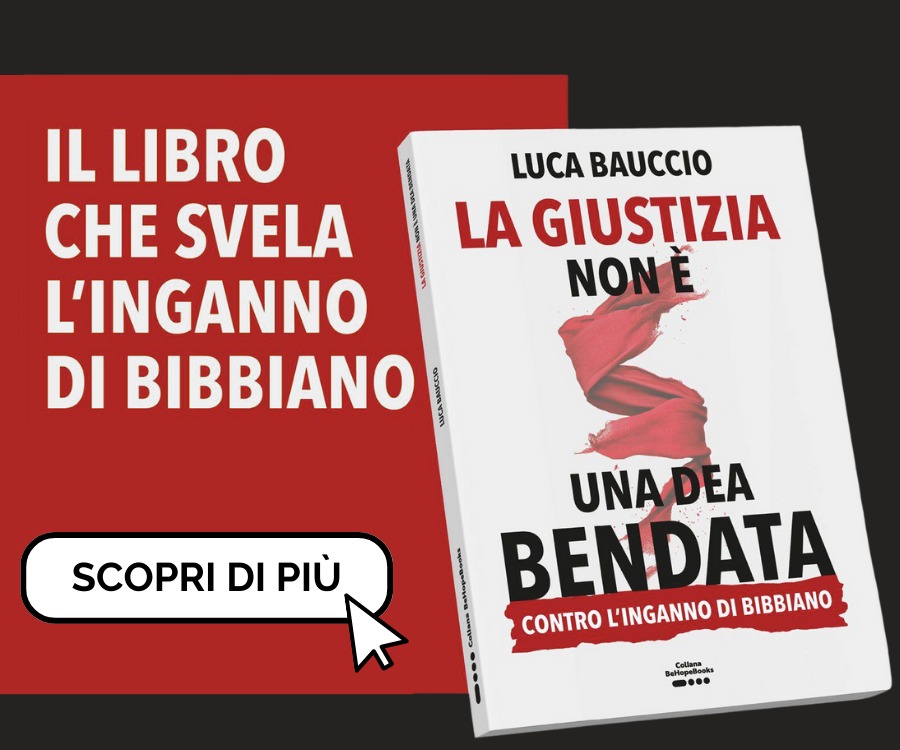PHOTO
Si è fatto prendere forse un po’ troppo la mano Matteo Salvini nel suo comizio a Pescara, per quanto comprensibilmente indispettito dalla decisione di Giuseppe Conte, che forse già conosceva, di rovesciargli addosso tutta intera la responsabilità della crisi con un monologo a Palazzo Chigi in cui avrebbe opposto la laboriosità del governo da lui presieduto alle “spiagge” preferite dal suo vice leghista e ministro dell’Interno. Eppure i grillini avevano da poco messo il presidente del Consiglio, non a caso tenutosi lontano dall’aula del Senato, in una situazione incredibile contestando di fatto con una mozione il suo sì alla Tav.
Con gli occhi, la mente, il cuore e chissà cos’altro rivolti agli elettori da lui già immaginati alle urne in autunno, senza aspettare neppure per cortesia lo scioglimento delle Camere spettante solo al capo dello Stato Sergio Mattarella, prudente ma gelosissimo, come tutti i predecessori, di questa prerogativa conferitagli dall’articolo 88 della Costituzione, col solo vincolo di sentirne prima i presidenti, Salvini ha detto, fra l’altro: «Se devo mettermi in gioco, lo faccio sereno, da solo e a testa alta. Poi potremo scegliere i compagni di viaggio, purchè non mi si venga a parlare di un governo sostenuto da Scilipoti vari», cioè da transfughi e avventizi.
Sfrattato Conte da Palazzo Chigi prima ancora di presentare al Senato la mozione che lo sfiducerà, Salvini sembra avere sfrattato, con quelle parole a Pescara, Silvio Berlusconi dalla postazione di alleato del centrodestra pur operante in tante amministrazioni locali. In teoria, se i sondaggi non gli suggeriranno altre scelte alla luce della legge elettorale in vigore, dovrebbe considerarsi sfrattata dalla postazione di alleata anche Giorgia Meloni con i suoi “fratelli d’Italia”, sovranisti come il “capitano” leghista.
Salvini evidentemente sente il vento in poppa con quel 38 per cento attribuitogli dagli aruspici elettronici anche dopo le polemiche a dir poco fastidiose cavalcate dalle opposizioni politiche e mediatiche sui presunti finanziamenti cercati per la Lega in Russia da persone indagate a Milano.
Mentre molti si sono confrontati e si confrontano sui personaggi della storia repubblicana italiana cui paragonare Conte, chi indicando Giulio Andreotti, chi Aldo Moro e chi Mario Monti, il leader leghista ha giocato davvero d’azzardo paragonandosi, forse senza neppure rendersene conto, addirittura ad Alcide De Gasperi. Che nelle storiche elezioni politiche del 18 aprile 1948, con un’affluenza alle urne del 92,19 per cento, impensabile nei giorni e anni nostri, portò da sola la Dc al 48,51 per cento dei voti. E ciò nonostante, peraltro, pur disponendo di 305 deputati e 131 senatori, grazie ai quali avrebbe potuto tentare la formazione di esecutivi monocolori democristiani, egli preferì fare governi di coalizione con i liberali, i repubblicani e i socialdemocratici. L’aggettivo “solo” terrorizzava quel pur coraggioso statista che fu l’artefice politico della ricostruzione dell’Italia e delle sue scelte internazionali. Esse furono così lungimiranti da indurre dopo tanti anni un segretario comunista come Enrico Berlinguer a sentire l’autonomia del suo Pci più sicura e protetta, rispetto ai condizionamenti di Mosca, sotto l’ombrello dell’alleanza atlantica.
Fa una certa impressione, via, affiancare Salvini, e la sua Lega, a De Gasperi e alla sua Dc, anche se riconosco che la Lega di Umberto Bossi agli inizi degli anni Novanta decollò al Nord in zone di forte radicamento democristiano. Dove però non era stata gradita la meridionalizzazione dello scudo crociato avvenuta durante la lunga e vigorosa segreteria del partito di Ciriaco De Mita.
Le vocazioni maggioritarie, chiamiamole così, per non chiamarle addirittura solitarie, non hanno del resto portato fortuna a nessuno che le abbia coltivate. Non la coltivò d’altronde neppure De Gasperi, che non avendo perseguito la maggioranza assoluta, per fare “da solo”, commentò i risultati delle elezioni del 1948 con la celebre battuta: «Credevo che piovesse, non che grandinasse».
Bettino Craxi, che non scherzava certo per ambizioni e temperamento, volle sfidare nel 1991 tutti i partiti più radicati nella politica italiana, esclusa quindi la Lega fresca di esordio, contrastando con una campagna astensionistica –“andate al mare”- il referendum contro il sistema elettorale delle preferenze plurime. E perse rovinosamente.
Nel 2016 l’allora presidente del Consiglio e segretario del Pd Matteo Renzi volle affrontare da solo il referendum sulla sua riforma costituzionale, perdendolo altrettanto rovinosamente, sia pure col 40 per cento dei consensi, pari alla percentuale dei voti raggiunti nelle elezioni europee di due anni prima. Pertanto egli chiese a Mattarella un ricorso anticipato al rinnovo delle Camere che gli fu però negato.
Berlusconi negli anni del suo centrodestra, quando cominciò ad avvertire difficoltà nella gestione degli alleati, prese l’abitudine di rimproverare e persino insultare gli elettori per non avergli dato i numeri per governare da solo. Ma quelli gli risposero non aumentando, bensì riducendogli progressivamente i voti, sino a farlo sorpassare da Salvini l’anno scorso e ora, nei sondaggi, persino dalla Meloni.
Fu sfortunata la vocazione maggioritaria rivendicata alla nascita del Pd, nel 2007, dal suo fondatore e primo segretario Walter Veltroni, letteralmente sfibrato dai cespugli di sinistra e di destra, da Fausto Bertinotti a Clemente Mastella, che avevano strozzato quasi nella culla entrambi i governi di Romano Prodi.
Consapevole dell’obiettivo troppo ambizioso che si era proposto nelle elezioni anticipate del 2008, dopo la caduta del secondo governo Prodi, il povero Veltroni chiese aiuto ad Antonio Di Pietro e alla sua Italia dei Valori, apparentandoli col Pd. Ma ciò non solo non gli consentì di evitare l’ultima vittoria elettorale del centrodestra di Berlusconi, e relativo governo, ma alla fine gli rese così problematica la gestione dell’opposizione, su posizioni anche di oltranzismo giustizialista, da fargli perdere la segreteria del partito.
A questa storia poco fortunata, e parziale, dei solitari, dei quali potrei scrivere ancora più a lungo, appartiene anche il monito che una volta Aldo Moro rivolse al pur amico, molto amico Carlo Donat- Cattin, perplesso sul passaggio della “solidarietà nazionale” col Pci fra il 1976 e il 1978, l’anno peraltro della tragica morte del presidente della Dc, assassinato dalle brigate rosse. “E’ meglio sbagliare in compagnia che avere ragione da soli”, gli disse Moro.