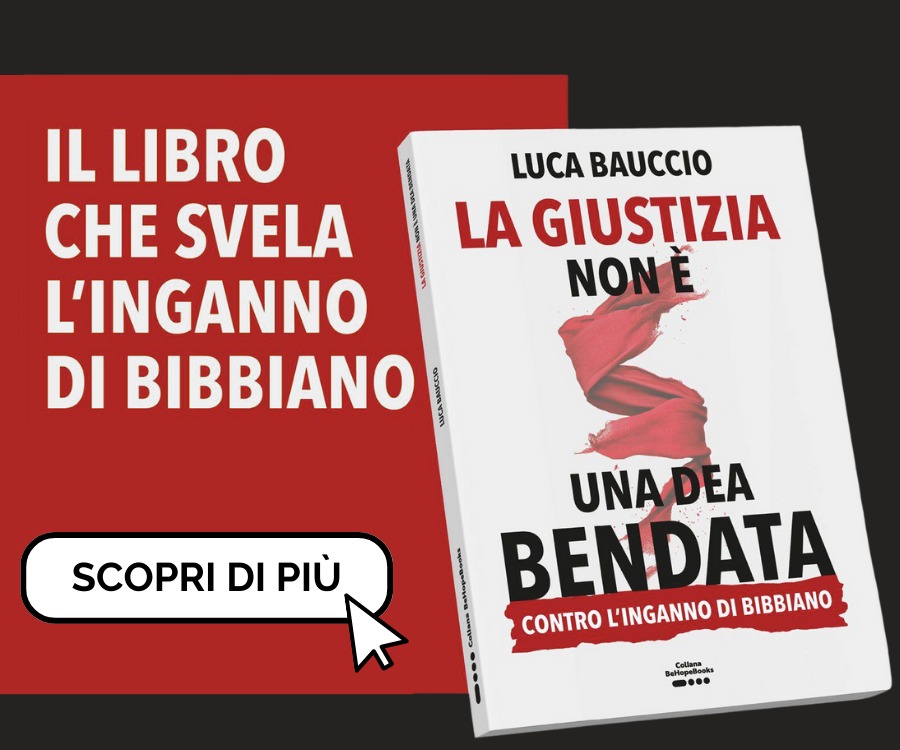PHOTO
Quando Renzi, rassicurante, ha garantito che comunque vadano le elezioni lui non mollerà la segreteria del Pd sono stati in molti a reagire col sarcasmo: «Se promette di restare è la volta che se ne va». Un po’, certo, dipende da quelle incaute frasi pronunciate dal medesimo e dall’allora sua ministra Maria Elena Boschi alla vigilia del referendum sulla riforma costituzionale del 2016: «Se perdiamo lasciamo la politica». Ma molto di più dipende dalla una sfiducia nelle promesse dei politici anche quella inversamente proporzionale alla fragorosità delle stesse.
Certo, qualche picco più vistoso c’è stato. L’Africa di Veltroni, metà annunciata con solennità dall’allora sindaco di Roma, poi rinviata, ma per carità solo rinviata, per rispondere con sofferto sacrificio alla chiamata del neonato Pd che lo voleva segretario e poi, conclusa mestamente quell’elevata missione, passata definitivamente in cavalleria. I solenni impegni di tutti i partiti a limitare il numero delle legislature consentite ai suoi parlamentari, spesso violati grazie a provvidenziali ' deroghe'. Il culto delle primarie, celebrato da tutti i partiti ogni anno con la sola eccezione di quello precedente le elezioni, perché lì alle segreterie neppure gli passa per la testa di perdere il controllo prezioso sulla selezione della truppa. Poi qualche fragoroso impegno tradito, a destra come a sinistra: i ruggiti di Bossi sull’imminente espulsione di tutti i clandestini, prologo, per fortuna, a una sanatoria formato gigante. Le 35 ore settimanali di lavoro promesse da Prodi a Bertinotti, e a tutto l’elettorato di sinistra, alla fine del 1997 e poi dimenticate una volta svanito, momentaneamente il rischio di crisi di governo. In fondo il più leale del mantenere gli impegni, inclusi quelli non pubblicamente assunto, è stato proprio il vituperato Massimo D’Alema, il solo premier ad aver rassegnato le dimissioni dopo una cocete sconfitta elettorale, nelle regionali del 2000, uno dei pochi, nel 2013 a non aver reclamato deroghe pur di rientrare in Parlamento Ma tutto questo, gli impegni personali e quelli politici allo stesso modo disattesi, è davvero solo la punta di un iceberg molto più profondo. La sfiducia degli elettori nelle promesse dei politici è cresciuta negli anni via via che l’abitudine di lanciarsi in promesse sempre più azzardare dilagava a macchia d’olio. Nella prima Repubblica i politici erano in realtà parchi di impegni, ci volevano le tenaglie per strappargli qualcosa che somigliasse a una promessa in campagna elettorale. Si tenevano sulle generali: più serietà, cavallo di battaglia preferito da Enrico Berlinguer, mantenimento e ampliamento della libertà, carta vincente per decenni della Democrazia cristiana. Qualche impegno a mezza bocca magari ci scappava, ma sempre con cautela. All’epoca era ancora avvertito il rischio che gli elettori prendessero sul serio parole pronunciate alla leggera e facessero poi pagare care eventuali delusioni. Sono una data, il 1994, e una promessa precisa a inaugurare il nuovo corso: quel «milione di posti di lavoro in più» sul quale Berlusconi basò la trionfale campagna nelle prime elezioni successive al referendum che aveva affondato il proporzionale. Oggi, dopo 24 anni di assuefazione e di dosi sempre più massicce di miraggi, sembra una cosetta da niente. All’epoca fu un colpo di genio pubblicitario. In una botta sola Berlusconi, il grande piazzista, aveva spostato la competizione elettorale sul suo terreno prediletto.
Non poteva scegliere momento migliore. Sino a quel momento, pur se in misura progressivamente decrescente, la sfida elettorale era stata condizionata a fondo dalle grandi appartenenze ideologiche: più che tra Pci e Dc la sfida era tra comunisti e anticomunisti. Potevano incidere, e anche in quel caso fino a un certo punto, i risultati concreti recenti, ma le promesse pesavano come piume e comunque non ce n’era bisogno. Erano i modelli alternativi di società le promesse che orientavano le scelte di moltissimi. Ma nel 1994, dopo la caduta del Muro e quella, in larga misura conseguente, della Prima Repubblica, quelle ideologie erano già fuori corso, con un effetto sul mercato del voto paragonabile a una gigantesca liberalizzazione.
L’onda è montata sempre di più. Berlusconi l’ha cavalcata meglio degli altri, raggiungendo il picco con la trovata del ' contratto con gli italiani' firmato in tv, ma gli epigoni sono stati innumerevoli. Non si sa se le elezioni del 4 marzo segneranno o no un successo del redivivo imbonitore. Di certo la campagna elettorale è stata la grande sagra del berlusconismo, l’apoteosi finale. Più che di elezioni bisognerebbe parlare di un voluminoso Libro dei Sogni, al quale tutti gli attori in campo hanno attinto a man bassa.
Per ironia della sorte, i fuochi artificiali che stanno festeggiando l’avvenuta e completa berlusconizzazione della politica, questo florilegio di promesse sempre più roboanti, sempre meno realizzabili, è conseguenza proprio dell’uscita di scena dello stesso Berlusconi come perno del sistema politico italiano. Il berlusconismo e a maggior ragione l’antiberlusconismo sono stati per due decenni la pallida imitazione delle ideologie forti su cui si era basato il voto nella prima Repubblica. Caduti anche quelli ( per fortuna) non conosce più limiti lo spazio per i piazzisti della politica e per le loro promesse. Con annessa costitutiva sfiducia nelle stesse del pubblico votante.