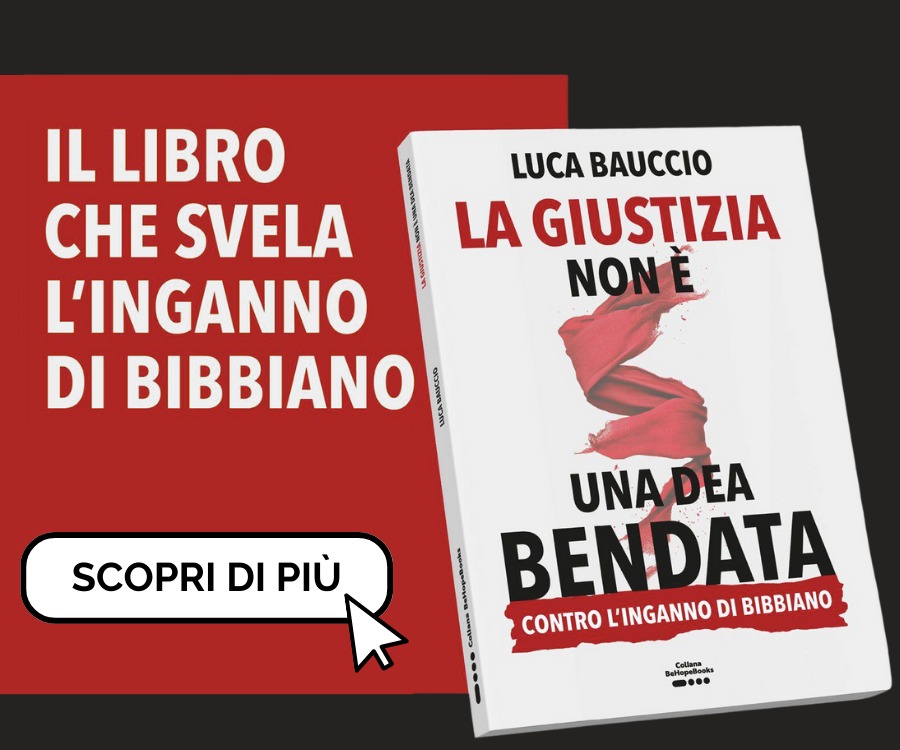PHOTO
Per tutti i giornali d’Italia erano «uomini della ‘ndrangheta di Marina di Gioiosa, malacarne» che avevano infettato l’amministrazione comunale del paesino calabrese lasciando una porta aperta a boss e gregari del clan Mazzaferro. Ma sei anni dopo, gran parte dei quali passati in carcere, il blitz “Circolo Formato”, che ha spazzato via la giunta della “città del sorriso”, il teorema della Dda è crollato in Cassazione. È una bocciatura la sentenza pronunciata ieri notte, dopo 10 ore di camera di consiglio, dai giudici della Suprema Corte, che hanno annullato con rinvio la condanna a 10 anni dell’ex sindaco Rocco Femia, rimasto in carcere per cinque anni con l’accusa di essere uomo del clan, e assolto per non aver commesso il fatto gli ex assessori Rocco Agostino (che era stato condannato a 7 anni) e Vincenzo Ieraci (9 anni e 4 mesi), anche loro ritenuti dall’accusa parte dell’organico della cosca. Prima di loro, in abbreviato, la Cassazione aveva assolto l’altro ex assessore coinvolto, Francesco Mazzaferro. Toccherà ora ad una nuova sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria valutare le condotte dell’ex sindaco e stabilire se avesse o meno fatto patti con la ‘ndrangheta. «Una battaglia legale certamente non ancora terminata per lui – ha commentato Marco Tullio Martino, legale, assieme ai colleghi Eugenio Minniti e Franco Coppi, di Femia - ma che sta, con questo annullamento, rendendo giustizia ad un sindaco ingiustamente travolto da accuse che non gli appartenevano». I legali hanno evidenziato che era l’intera comunità ad essere interessata alle elezioni del 2008, «con contatti ed intercettazioni dunque anche con soggetti eventualmente facenti parte di contesti malavitosi», ma che nonostante questo l’accusa «non aveva mai saputo dimostrare l’elargizione di un solo appalto, di una concessione o di un solo finanziamento, diretto o anche solo indiretto, a qualsivoglia consorteria di riferimento». Gli avvocati hanno spulciato tutti gli atti di tre anni di amministrazione, le singole assegnazioni, dirette solo nei casi di lavori da pochi centinaia di euro, e sempre affidati alla stazione unica appaltante provinciale anche quando sotto soglia, «proprio per fugare ogni dubbio di interferenze». Un imponente accesso agli atti teso a dimostrare che la giunta non aveva mai aiutato il clan a recuperare terreno sul clan rivale, economicamente e militarmente più forte dei Mazzaferro. Anzi, sostiene Martino, l’amministrazione aveva contrastato la cosca a suon di atti. «Dalla documentazione prodotta erano emerse demolizioni, sequestri e provvedimenti mirati, che avevano colpito proprio i beni immobili del sodalizio mafioso che si voleva considerare in realtà vicino alla giunta», ha evidenziato. Le sentenze di primo grado e d’appello avevano definito le elezioni del 2008 «una competizione elettorale tra ‘ndrine», un conflitto silente, «camuffato da una competizione elettorale, di contrapposizione mafiosa tra i Mazzaferro e gli Aquino, che misurano così la loro forza su quel territorio». La vittoria finale, secondo le accuse della Dda di Reggio Calabria, avrebbe comportato il governo del paese ed il conseguente arricchimento di una ‘ndrina a scapito dell’altra, grazie al controllo degli appalti, dell’economia, insomma: del denaro pubblico. Secondo la Dda, Femia era uno dei politici in grado di inserire il clan nei gangli dell’economia di Marina di Gioiosa. Anzi, il numero uno tra i soggetti prescelti. «Il mondo mi è crollato addosso. Non mi sarei mai aspettato di finire in carcere con questa pesante accusa», aveva raccontato al Dubbio, poco dopo la scarcerazione, Femia. «Ho sofferto tantissimo. Insegno educazione fisica da 30 anni, ai miei ragazzi ho sempre parlato del rispetto delle regole – ha spiegato -. Vedere che tutto questo sarebbe andato perduto mi ha distrutto». Da quel giorno sono passati cinque anni prima di poter passare un’altra notte a casa con la propria famiglia. Cinque anni durante i quali non ha fatto altro che ripetere la sua versione dei fatti. «Ribadisco quello che ho sempre detto sin dal mio primo giorno: non ho niente a che fare con la ‘ndrangheta, non ne ho adesso e non ne avrò nel futuro. Questa parola non è mai entrata in casa mia», sottolineava, difendendo a spada tratta anche la sua amministrazione, fatta «di uomini liberi», di gente che «ha sempre agito nella massima legalità, trasparenza e democrazia. Tutto questo lo affermano i fatti, le prove, ma purtroppo, non so perché, c’è stato un accanimento violento nei nostri confronti. Su di noi non c’è niente».
La sentenza d’appello, depositata qualche giorno dopo la scarcerazione, aveva però abbracciato la tesi della Dda, con un pesante giudizio sull’ex sindaco. Per i giudici che aveva confermato i 10 anni di carcere, il politico era al soldo della cosca Mazzaferro. Di più: di quella cosca lui avrebbe fatto parte, rendendosi strumento del tentativo del clan di risalire la china. Un teorema che ora andrà dimostrato nuovamente in appello, mentre la città, lentamente, si risveglia da un torpore durato 6 anni. «Dove sono le telecamere adesso?», si chiedono i parenti degli ex amministratori ora scagionati. Che ringraziano: «è la fine di un incubo che mai avrei pensato di vivere – ha commentato Rocco Agostino -. Credo comunque nella giustizia e nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine. Ora mi godo la mia famiglia, poi in futuro chissà».