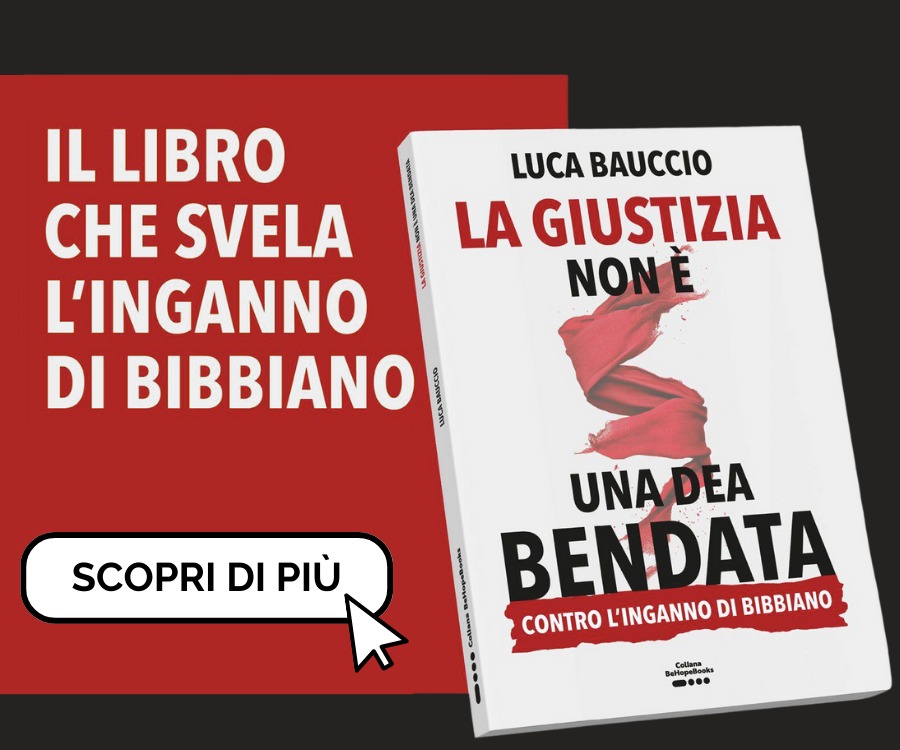PHOTO
«Un'organizzazione per i diritti umani non può sostenere la tesi che niente è meglio di poco, perché le battaglie per i diritti umani si fanno anche con gradualità». Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, si riferisce alla legge che introduce nel nostro ordinamento il reato di tortura, approvata definitivamente dalla Camera, tra polemiche e contestazioni, mercoledì 5 luglio con 198 voti a favore, a 33 anni di distanza dalla ratifica della Convenzione Onu. La legge sulla tortura recentemente approvata dal Parlamento ha attirato, fra le altre, le critiche del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Nils Miuznieks. Siete soddisfatti da questa legge? Bisogna rilevare che, dopo ventotto anni, il Parlamento non è riuscito a produrre niente di meglio di una legge confusa, eccessivamente lunga e di applicazione non semplice. Ciò nonostante, il fatto che con questa legge – che ha comunque dato fastidio a molti – si sia spezzato il tabù di non poter parlare di tortura in Italia perché nessuno voleva che venisse menzionata nel codice penale, rappresenta senz'altro un risultato cui guardiamo con soddisfazione. Questa legge è frutto di un compromesso tra i centristi di Ap e il Pd: la tortura non viene considerata un reato specifico ma un reato comune, con un'aggravante in caso di abuso di potere... La Convenzione di New York del 1984 contro la tortura prevede che vi sia un reato specifico di tortura – che non sia confuso con altri reati – e, contestualmente, una legge che lo disciplini specificamente. Considerare qualsiasi atto da chiunque compiuto che manifesti una gravità tale da poterlo definire tortura, con un'aggravante se commesso da pubblico ufficiale, costituisce un compromesso che, sebbene non incompatibile con la Convenzione, ha evidenziato fin da subito quanto l'obiettivo fosse quello di non dare l'idea di fare qualcosa che fosse rivolto esclusivamente alle forze di polizia. Cosa pensa dei punti più contestati della legge – come ad esempio la frase introdotta al Senato «Se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona» o i riferimenti alla «privazione di libertà personale» e al «verificabile trauma psichico» – rilevati da insigni giuristi come Vladimiro Zagrebelski? Sostenere fin da oggi che questa legge non sarebbe applicabile in nessun caso sia nel passato che nel futuro non è dimostrabile. Quelle criticità riferibili alla reiterazione e al “verificabile trauma psichico” sono conseguenza, nella fattispecie delle possibili applicazioni, di una volontà tesa a escludere più che a includere. Ci hanno tuttavia chiarito che quella congiunzione “ovvero” che segue la reiterazione è una congiunzione contrattiva, per cui o ci sono condotte reiterate oppure – «ovvero» – c'è un trattamento inumano e degradante che, nel qual caso, è di per sé tortura anche qualora venisse a mancare la reiterazione. A suo avviso, sarà difficile dare piena ed efficace applicazione a questa legge? Usiamo ovviamente il condizionale, in quanto saranno i giudici a decidere caso per caso se applicare la legge. La Slovenia, al riguardo, ha una legge perfetta, di cui nessuno avrebbe motivo di lamentarsi, di cui tuttavia non si registra alcuna applicazione. Non bastano le leggi, occorre la volontà di applicarle; ciò detto, se una legge è il più possibile coerente possibile alla Convenzione di New York, l'applicazione diventa più semplice. Secondo lei, perché in Italia si è indugiato tanto per varare il reato contro la tortura, giungendo peraltro solo ad una soluzione di compromesso? In tutte queste legislature il motivo per cui ogni proposta si è fermata è stato sempre lo stesso: una specie di equivoco – neanche particolarmente innocente – che tale legge avrebbe potuto danneggiare le forze di polizia. C'è stato un ostacolo da parte dei sindacati di polizia. Abbiamo sempre sostenuto che una legge sulla tortura avrebbe avuto un valore di prevenzione e di punizione ma anche che avrebbe consentito a quell'enorme percentuale di operatori di polizia che svolgono il proprio mestiere con grande professionalità e sacrificio di avere salva la loro onorabilità e di non venire mescolati ad altri che hanno commesso reati di questo genere. A proposito di “situazioni inumane e degradanti”, cosa può dirci riguardo i centri per i migranti in Libia, con cui l'Italia stipulò diversi accordi sul pattugliamento delle coste e il recupero dei migranti? Abbiamo resoconti terribili di stupri, torture feroci, vendita di esseri umani fra bande, con un accanimento particolare nei confronti delle donne cristiane, le quali, giunte in Libia dopo un viaggio tortuoso, non potendo dimostrare di essere musulmane subiscono una discriminazione, una violenza sia di genere che religiosa. Ciò nonostante, abbiamo stipulato in meno di dieci anni quattro distinti accordi con diverse autorità libiche – da Gheddafi a coloro che gli sono subentrati –, tutti con lo stesso obiettivo, ovvero impedire le partenze dalla Libia a qualunque costo, e in questo caso il costo è trattenere i migranti in quei centri di detenzione dove si pratica la tortura. Attualmente stiamo rafforzando la capacità della guardia costiera libica, in modo che chi riesce a partire venga riportato indietro esattamente in quei luoghi. Anche l'Italia, quindi, ha le sue responsabilità in merito? Politicamente esistono delle responsabilità, in quanto ci si rende complici di gravi violazioni dei diritti umani. Nel momento in cui le indagini in corso della procuratrice della Corte penale internazionale dovessero stabilire che effettivamente in Libia vengano commessi crimini contro l'umanità e venissero chiamati in causa tanto la guardia costiera – su cui si sta indagando – quanto coloro che gestiscono i centri di detenzione, per l'Italia sarebbe motivo di enorme imbarazzo la sua collaborazione con chi è sospettato e sarà eventualmente processato per crimini contro l'umanità. Le responsabilità andrebbero estese, in un certo senso, anche alle politiche dell'Unione Europea sull'immigrazione? Le responsabilità dovrebbero essere comuni. Poiché in questo momento non vengono condivise le responsabilità dell'accoglienza e del soccorso in mare, l'unica cosa di cui ci si rende corresponsabili sono i crimini contro l'umanità. È un po' come nascondere il problema sotto il tappeto, solo che in questo caso il tappeto sarebbe rappresentato dalla Libia... Si dice che queste misure – limitare le partenze, rafforzare la guardia costiera libica – eviteranno morti in mare, ma il problema è che li aumenteranno sulla terraferma, dove nessuno controllerà. In mare, finché saranno lasciate lavorare, ci saranno le Ong a monitorare, salvare, controllare le testimonianze, mentre in Libia non c'è nessuno. Cosa ne pensa delle nuove regole di condotta abbozzate per le Ong? Da un lato sono superflue, perché alcune delle regole di questo nuovo codice di condotta le Ong le hanno sempre rispettate, mentre dall'altro si tratta di misure che nascono da un sospetto: ci troviamo in una situazione orwelliana in cui le Ong rappresentano il problema e la Libia la soluzione, mentre dovrebbe essere esattamente il contrario. L'idea che alle Ong venga chiesto di non operare nelle zone in cui c'è maggiore necessità di ricerca e soccorso renderà molto meno utile il loro lavoro e aumenterà il numero di morti in mare.