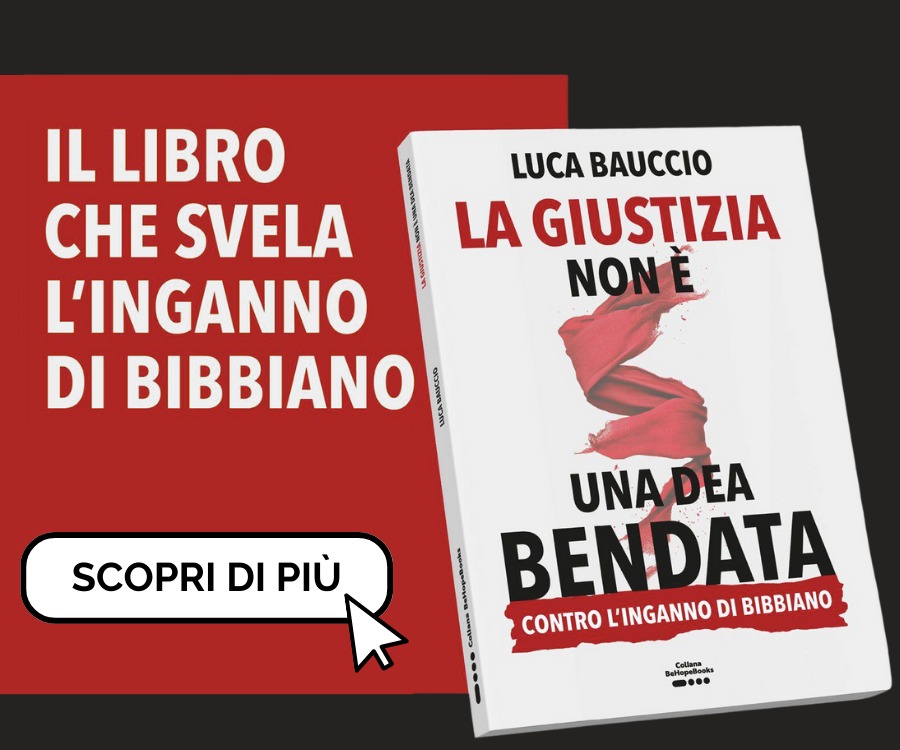PHOTO
Con Nicolò Amato, magistrato e poi avvocato di lunghissimo corso, professore universitario di filosofia del diritto, autore di un lunghissimo elenco di libri e saggi scientifici, appena spentosi serenamente a 88 anni nella sua abitazione vicino Roma, è scomparso l’ultimo capo degno di questo nome di quello che conosciamo come Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. In particolare, egli fu capace in dieci lunghissimi e terribili anni, fra il 1983 e il 1993, di fare della “complessità” congenita della realtà carceraria “un mix progettuale efficace”. Lo ha riconosciuto in un’intervista al manifesto il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma. “Capacità - ha precisato- che, mi spiace dirlo, non ho più trovato successivamente”.
Eppure a un così straordinario servitore dello Stato capitò negli ultimi mesi della sua direzione del Dipartimento penitenziario, tra febbraio e giugno del 1993, la paradossale avventura di essere contestato per la sua fermezza in un documento anonimo inviato come una circolare dai vertici mafiosi a quelli dello Stato e persino al Papa, in cui se ne reclamava la testa, e di essere rimosso dall’allora ministro della Giustizia Giovanni Conso con la formale promozione a rappresentante dell’Italia nel comitato europeo per la prevenzione della tortura. Ci fu un sadismo involontario - spero per la memoria di Conso in quella destinazione perché di tortura puzzò subito proprio quella decisione. Dalla quale l’orgoglioso e valente magistrato, che aveva seguito vicende terroristiche complesse come il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e l’attentato a Giovanni Paolo II, si sfilò a beneficio della professione e dell’ordine forense. Dove ha lasciato il segno ancor più che nella magistratura prodigandosi per una Giustizia, con la maiuscola, davvero giusta, secondo uno slogan dei radicali.
Difensore, fra gli altri, dell’ex presidente del Consiglio Bettino Craxi, egli scrisse sui processi del cliente ed amico dall’epilogo scontato con quel titolo così eloquente -“Bettino Craxi dunque colpevole” - un libro che a rileggerlo dopo tanti anni dalle condanne e dalla morte del leader socialista, la pelle spesso si accappona ancora. È un libro privo di accanimento verso gli ex colleghi magistrati lasciatisi trascinare praticamente dalla piazza, qualche volta persino in buona fede. Ma sono risultati devastanti i suoi effetti sulla giustizia. Della cui gestione l’autore si mostra via via più angosciato, incredulo di fronte anche a quella enormità della latitanza contestata a Craxi persino dalla Cassazione, nonostante egli avesse lasciato l’Italia con tanto di passaporto valido, regolarmente e non fuggendo. Ma la latitanza doveva servire a demonizzare ulteriormente l’immagine dell’uomo e la memoria, anche dopo la morte.
Penso che il libro di Nicolò Amato non fosse stato estraneo alle considerazioni maturate al Quirinale da Giorgio Napolitano in occasione del decimo anniversario della morte di Craxi. Alla cui vedova, fra le critiche e gli insulti dei soliti giustizieri, l’allora capo dello Stato ebbe il buon senso e il coraggio di mandare, su carta intestata della Presidenza della Repubblica, un messaggio per riconoscere “la severità senza uguali” praticata dalla magistratura contro l’ex presidente del Consiglio. “Senza uguali” significa arbitrariamente, ingiustamente, se ha ancora un senso “la legge uguale per tutti” che è stampata o scolpita sulle pareti delle aule nei tribunali.
Per tornare all’esperienza di capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria contestato per la sua durezza dalla mafia - e rimosso da un ministro della Giustizia finito poi sotto inchiesta giudiziaria per avere disposto, dopo l’allontanamento di Nicolò Amato, l’allentamento del cosiddetto carcere duro dei detenuti di mafia, nella presunzione, dichiarò ai magistrati, di ridurre la tensione nella quale erano maturate le stragi mafiose di quei tempi- va detto con tutta onestà che il guardasigilli non si mosse nel pieno della sua autonomia. Di come e con chi sostituire il capo dell’amministrazione penitenziaria si occupò personalmente l’allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro parlandone col capo dei cappellani delle carceri.
Nicolò Amato avrebbe avuto più di una ragione per accusare Scalfaro di interferenza. Ma glielo impedì forse il suo senso dello Stato, lamentandosi genericamente solo di “qualcuno” che di fatto raccolse, esaudì e quant’altro la richiesta di decapitazione avanzata dalla mafia. A ciascuno il suo stile. Quello di Amato era di rispettare comunque le istituzioni, al servizio delle quali aveva lavorato, pur avendone subito alla fine un torto immeritato. Non mi sembra proprio lo stile - scusatemi lo sconfinamento nelle cronache politiche e giudiziarie di questi giorni - di quei servitori in toga dello Stato che stanno sommergendo di accuse e persino di insulti uomini e donne di governo che legittimamente, nell’esercizio delle loro funzioni, sono alle prese con la riforma del processo penale imposta da vecchi e nuovi mali della Giustizia. E fra i nuovi mali si deve purtroppo annoverare la mancata riforma del processo per la quale si era invece impegnato il primo governo di Giuseppe Conte introducendo come una supposta in una legge sulla corruzione la fine della prescrizione con l’esaurimento del primo grado di giudizio. Per cui, a legislazione lasciata invariata dal secondo governo Conte, persino all’assolto con sentenza impugnata dall’accusa per reati compiuti dal primo giorno di gennaio dell’anno scorso potrebbe accadere di rimanere imputato a vita. È rimasta infatti appesa solo alle parole - niente di più - la “ragionevole durata” del processo, di ogni grado, sancita dall’articolo 111 della Costituzione.