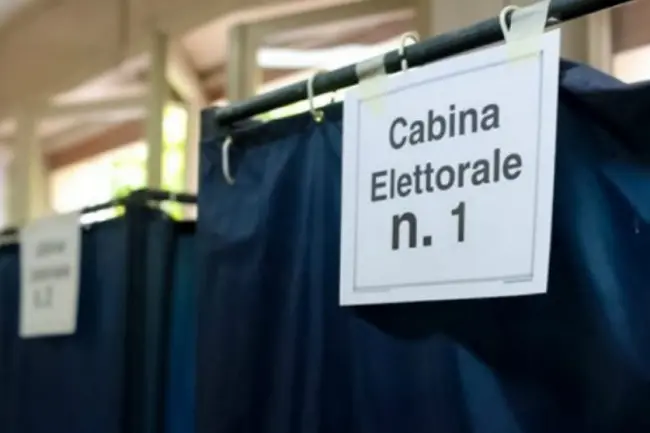PHOTO
Per gentile concessione dell’autore, pubblichiamo uno stralcio del saggio comparso sull’ultimo numero della rivista Federalismi. it
We did it, ha cinguettato Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo, abbracciando Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione, la mattina del 21 luglio, dopo aver concluso un lunghissimo e faticosissimo vertice europeo (...). Dovrebbero dunque arrivare in Italia dall’Europa oltre 200 miliardi di euro. A questo punto siamo noi che dovremmo domandarci: Shall We overcome?, «Ce la faremo ( ad utilizzarli)?». E, infatti, nei prossimi mesi, il governo - nella sua attuale composizione giallorossa - è chiamato ad affrontare nodi istituzionali da far tremare le vene dei polsi, e ciò al di là della capacità di costruire programmi in grado di spendere in modo soddisfacente l’ingente somma appena ricordata ( pari a circa un quarto della spesa pubblica annua nazionale).
Il 20- 21 settembre si giocherà una doppia partita politica e istituzionale: sette Regioni ( Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia) e circa 1000 comuni vanno al voto e si voterà il referendum approvativo della riforma costituzionale che riduce i parlamentari a 400 deputati e 200 senatori. Al di là dell’aggiramento di un possibile principio ( sul cui rango sarà chiamata a giudicare la Corte costituzionale il 12 agosto p. v.) che non permetterebbe l’accorpamento del referendum costituzionale con le elezioni regionali e locali, le due partite si intrecciano inesorabilmente, tanto che la buona intenzione di arrivare al referendum con una proposta di legge elettorale approvata almeno in una Camera è finora fallita ed è probabilmente destinata al fallimento.
Anche se gli schieramenti per le regionali devono ancora essere compiutamente definiti ( i termini per la presentazione delle liste e dei candidati presidenti scadono intorno a metà agosto, cosicché le campagne elettorali si svolgeranno sulle spiagge o in città vuote!), a fine settembre si potrà capire come ne usciranno gli attori politici di questi due anni di “montagne russe” che ci separano dal voto politico ( 2018) e da quello europeo ( 2019). Ai sondaggi di questi mesi si sostituiranno voti reali, pur se resi in contesti diversi da quello politico generale e, soprattutto, nella consapevolezza della estrema volatilità del voto degli italiani.
Forse solo dopo le elezioni si potrà intuire - ma dubito che si capirà definitivamente - la direzione che prenderà il sistema politico italiano: se, cioè, archiviato il modello tripolare di questa secondo decennio, ci si muoverà ancora verso un sistema bipolare o se emergerà un’ipotesi politicamente valida di creazione di un’area centrale in grado di dirigere i giochi. Nonostante le spinte bipolari ( create anche dalla legislazione elettorale regionale e locale), resiste sottotraccia una tendenza centripeta, che non deriva solo dalla sommatoria dei voti di una possibile alleanza centrista o di centro- sinistra ( che, mettendo insieme Pd, Forza Italia e “cespugli” centristi, si avvicina al 40%), quanto dalla storia di questo Paese, almeno dal dopoguerra in poi: l’Italia è sempre stata governata al centro - anche nelle fasi più marcatamente bipolari -, osservando attentamente cosa succedeva a destra, con un occhio a possibili alleanze a sinistra.
Le due possibili alleanze bipolari scontano ancora oggi troppe contraddizioni: un centro- destra a trazione marcatamente leghista non è in grado di essere interlocutore credibile, né in Europa ( dove la Lega è isolata), né a livello mondiale ( troppi giri di walzer con la Russia!). Certo, i sondaggi sembrano indicare un crescente indebolimento della Lega, una crescita di Fratelli d’Italia e una collocazione di Forza Italia non soddisfacente sotto il profilo numerico, ma di grande interesse sotto il profilo strategico: quali saranno le ricadute politiche di ciò lo si potrà intuire solo il 22 settembre.
A sinistra, un’alleanza strategica Pd- Cinquestelle non sembra decollare, nonostante gli auspici di leader e consiglieri: troppo strutturalmente, ontologicamente diversi l’uno e l’altro per poter giungere ad una sintesi; se il Pd cede ad alcune pulsioni grilline ( tanto per dirne qualcuna: “uno vale uno”, giustizialismo, sentimento anticasta, sotterranea diffidenza verso verso l’Europa, di cui la battaglia contro il Mes è solo la punta dell’iceberg) rischia di perdere voti e consenso verso il centro; ma altrettanto vale, all’incontrario, per i Cinque Stelle: insomma, nonostante gli sforzi fatti in questa direzione in questo ultimo anno, non si riuscirà né a romanizzare i barbari, né a barbarizzare i romani; e non credo che a qualcuno piaccia attraversare, dopo la vittoria dei barbari, un lungo e cupo Medio Evo, prima di rivedere la luce. Al centro, poi, troppi galli cercano di dividersi un’area che sulla carta e anche senza Berlusconi potrebbe valere il 10% dei voti e oltre. Vedremo. Ma nel frattempo è difficile pensare che si riesca ad andare rapidamente verso una nuova legge elettorale.
Si è recentemente detto – e questa posizione sembra aver fatto presa nel dibattito politico – che l’approvazione della riduzione del numero dei parlamentari senza sapere con quale legge elettorale verrà votato il nuovo parlamento bicamerale ridotto da 930 a 600 membri sarebbe addirittura pericolosa per la democrazia. Verrebbe da dire al Pd: ci si poteva pensare prima ad accettare l’approvazione in quarta lettura della legge costituzionale dopo tre voti parlamentari contrari, o comunque i sostenitori di questa posizione potevano spingere di più in questi mesi per un progetto di ridisegno istituzionale o per la nuova legge elettorale. Ma tant’è! I danni ormai sono fatti! Grazie ad un manipolo di contestatori che hanno raccolto le firme per il referendum costituzionale, il 21 settembre si andrà comunque al voto anche per la riduzione del numero dei parlamentari.
È la classica battaglia di principio di un gruppo di intellettuali e di politici contro un sentimento di massa della popolazione: ma se nulla cambia in questo mese e mezzo, il risultato sarà schiacciante a favore di una riduzione, che nella peggiore tradizione antiparlamentare del Paese si baserà solo sull’argomento della riduzione dei costi della politica, senza nessun margine affinché siano introdotte valutazioni in ordine ad una maggiore efficienza istituzionale. L’elemento di novità potrebbe essere dato da quattro conflitti di attribuzione ( presentati dal Comitato per il no, da + Europa, dal senatore De Falco e dalla Regione Basilicata) contro il decreto di indizione del referendum fissato contemporaneamente alle elezioni regionali e locali. L’argomento secondo cui il referendum costituzionale ha una sua peculiarità che non ne permette l’accorpamento con altre tenzoni elettorali, dovendo l’elettore avere chiara la natura del quesito, non è banale e merita sicuramente un approfondimento, così come non è banale, pur se di fatto, l’argomento per cui l’accorpamento falsa la partecipazione al voto a favore delle regioni in cui si vota anche per altre consultazioni.
Tuttavia, al di là di profili processuali che appaiono problematici ( bisognerebbe sospendere, già all’esito della Camera di consiglio – senza parti – del 12 agosto, l’indizione del referendum e, per dare certezze, fissare l’udienza pubblica prima del 20 settembre: è processualmente possibile, v. sent. 161 del 1995), appare difficile, pur se non impossibile, che la Corte voglia mettere le mani dentro una vicenda per la quale ben si potrebbe rispolverare la vecchia categoria della political question.
La verità è che è chiaro ormai da mesi che di questo referendum non se ne parla e non se ne parlerà ( e la Corte potrebbe stigmatizzare questo silenzio): l’accorpamento con le elezioni regionali permetterà di non correre il rischio che vadano a votare solo i contrari al testo e un voto d’impulso, se non di pancia ( ridurre le poltrone, ridurre i costi della politica, colpire la casta!), farà passare il testo. D’altra parte, l’accorpamento potrebbe essere per i grillini il modo per non vedere un nuovo affossamento delle proprie liste, dopo quelli registrati alle elezioni europee e a tutte le elezioni regionali finora tenutesi. Per il giorno dopo ( sarebbe meglio qualche giorno prima, certo), per evitare, appunto, pericoli per la democrazia, bisognerà avere delle idee, recuperando quella tradizione di un dibattito politico che non aveva mai scartato o demonizzato l’ipotesi di una riduzione del numero dei parlamentari.
Una prima idea poteva essere quella, che personalmente avevo già espresso nella fase di formazione del governo giallorosso, di trasformare il Senato in Camera delle Regioni e delle autonomie, modificando il bicameralismo paritario verso una direzione confacente con la struttura istituzionale italiana e con il numero dei senatori: occorre, certo, una legge costituzionale, ma il nodo principale della possibile riforma avrebbe potuto ( e potrebbe ancora oggi) essere risolto facendo del Senato regionale una camera di ripensamento generale su tutta l’attività legislativa, lasciando sempre alla Camera dei deputati, oltre alla fiducia, la parola definitiva su tutta la legislazione, aggirando così faticosi riparti di competenza ed evitando di riscrivere un articolo sul riparto della legislazione tra le due Camere, tipico di tutti i modelli istituzionali federali o quasi federali, ma troppo complicato per i sessanta milioni di costituzionalisti che si agitano nel Paese quando si parla di riforme costituzionali.
Un’altra possibile idea sarebbe quella di conservare la vigente legge elettorale, ambiguamente mista, limitandosi ad adeguarla ai nuovi numeri, per la Camera, prevedendo una legge perfettamente proporzionale per il Senato, facendo del Senato proporzionale il soggetto dove vengono introdotte le riforme costituzionali, e attribuendogli così non il ruolo di una Assemblea costituente, bensì quello di una levatrice delle riforme. Una soluzione di questo tipo avrebbe il vantaggio di non impedire la eventuale conferma di un modello bipolare, lasciando la porta ad altre soluzioni nel caso di mancata formazione di una maggioranza politica sulla base del risultato elettorale. Il Senato, eletto con un sistema proporzionale, da un lato seguirebbe o accompagnerebbe la maggioranza politica che si forma alla Camera, dall’altro - grazie alla sua composizione - potrebbe essere il luogo dove far partire le riforme, nel rispetto poi dell’art. 138.
E per giungere a questa soluzione, non vi sarebbe nemmeno bisogno di un intervento costituzionale, ma basterebbe l’accordo politico a presentare le proposte di riforma nella sola Camera alta. Nell’Italia di oggi, in cui il dibattito politico si è esacerbato e imbarbarito, sono sogni, certo, ma qualche volta, se i sogni superano la fase del sonno profondo, vanno esternati, anche solo per testimonianza...
Il riassetto di cui ha bisogno l’Italia non riguarda solo il sistema dei partiti e la legge elettorale, ma tocca - in maniera altrettanto grave, pur se meno percepita dall’opinione pubblica generale - il complessivo assetto territoriale, per quanto riguarda i punti dolenti del regionalismo differenziato, del ruolo delle Province, della capacità di governo delle città metropolitane, della dimensione dei comuni e dei possibili modelli di accorpamento, della distribuzione delle funzioni e del loro finanziamento. Sono tutti temi a cui la pandemia aveva messo la sordina, ma riesploderanno in tempi brevi, tanto che il governo ha istituito due commissioni di studio, una per il regionalismo differenziato, per giungere ad una delega che riordini le proposte a suo tempo elaborate per Lombardia, Veneto, Emilia- Romagna, inserendole in un quadro di compatibilità nazionale; l’altra per la riforma del Tuel, mettendo le mani in primo luogo proprie sulle Province, sopravvissute alla riforma costituzionale bocciata nel 2016, ma uscite malissimo dalla riforma Delrio.
Non è questa la sede per discutere nuovamente l’uso delle fonti nella fase di emergenza da parte del governo Conte2, né per entrare nell’analisi ravvicinata del contenuto dei diversi decreti legge adottati, né per valutare il primo caso di applicazione dell’art. 120 Cost., avvenuto solo qualche giorno fa con un decreto legge in materia elettorale con la posizione contraria delle opposizioni. Ci sarà tempo e modo per riprendere anche il tema se questa disinvoltura nell’uso delle fonti debba iniziare a preoccupare e a destare qualche allarme anche al di là della comprensione della situazione particolarissima creata dalla pandemia.
Per quanto riguarda i decreti legge, forte è la sensazione che sarà difficilissimo attuarli, in ragione dei numerosissimi adempimenti richiesti alle diverse amministrazioni, del cui potenziamento, in realtà, i diversi interventi poco si occupano. Al di là di ogni valutazione sugli effetti, si spera positivi, delle misure previste negli atti governativi, quel che è certo è anche questo governo si trova di fronte a difficoltà strutturali ( quelle che richiedono riforme sia di rango legislativo che di rango costituzionale), che derivano non tanto e non solo da deficit politici e culturali, bensì da deficit istituzionali, consistenti nella ricorrente mancanza di strumenti congrui per assumere le decisioni o per bilanciare i diversi interessi e le diverse situazioni soggettive che vengono in gioco. E, senza dover riprendere in mano un lungo cahier de doleances ( in cima al quale c’è ormai l’emergenza scuola), valgano tre esempi tratti dal recente decreto legge semplificazioni. Qui, affianco a misure ( decorrenza di termini, modifica di distanze, ecc.) che è congruo assumere con decreto legge ( anzi, sarebbe meglio poter assumere con atti secondari), vi sono veri e propri interventi strutturali, per i quali lo strumento del decreto legge è, per ragioni politiche e giuridiche, lo strumento meno adatto, giacché impedisce la discussione – prima, durante e dopo – su misure che possono modificare il futuro istituzionale del Paese. Faccio riferimento all’art. 4, c. 4, che cerca di trasformare - in modo poco rispettoso dei diritti della difesa e della stessa struttura del processo - il giudizio cautelare amministrativo in giudizio di merito, snaturando ambedue le fasi ( ma se non ci pensa il legislatore, interverrà la saggia giurisprudenza del Consiglio di Stato); all’art. 21, c. 2, che elimina a tempo, fino al 31 luglio 2021, la colpa grave nei casi di danno erariale in materia di lavori pubblici ( che verrebbe sanzionato solo nei casi di dolo), ma solo in caso di azione, e non inerzia e omissione ( come se la colpa grave non costituisse di per sé un grave vulnus, che caso mai va tipizzato, non abolito; e come se fosse possibile gli eventi dannosi fossero caratterizzati solo dalla presenza dell’una o dell’altra modalità dì comportamento: si tratta, in verità, di un modo molto grossolano per dire all’amministrazione “se agite l’ordinamento sarà più comprensivo”); e all’art. 23, che modifica l’art. 323 del codice penale sull’abuso di ufficio, cercando - giustamente - di proteggere gli spazi di discrezionalità dell’amministrazione e della politica, riducendo le difformi interpretazioni dei giudicanti e delle Procure.
Al di là del giudizio sugli interventi ( comunque fortemente negativo per i primi due e di cauta attenzione per l’intervento sull’abuso d’ufficio, ormai non più rinviabile), risalta l’ incongruità dello strumento: situazione che accomuna il governo Conte2 a tutti i governi della Repubblica e che deriva dalla mancanza di un strumento - diverso dal decreto legge - che garantisca al governo l’attuazione del suo programma, in fasi normali o in fasi eccezionali. E anche qui: Shall we overcome?