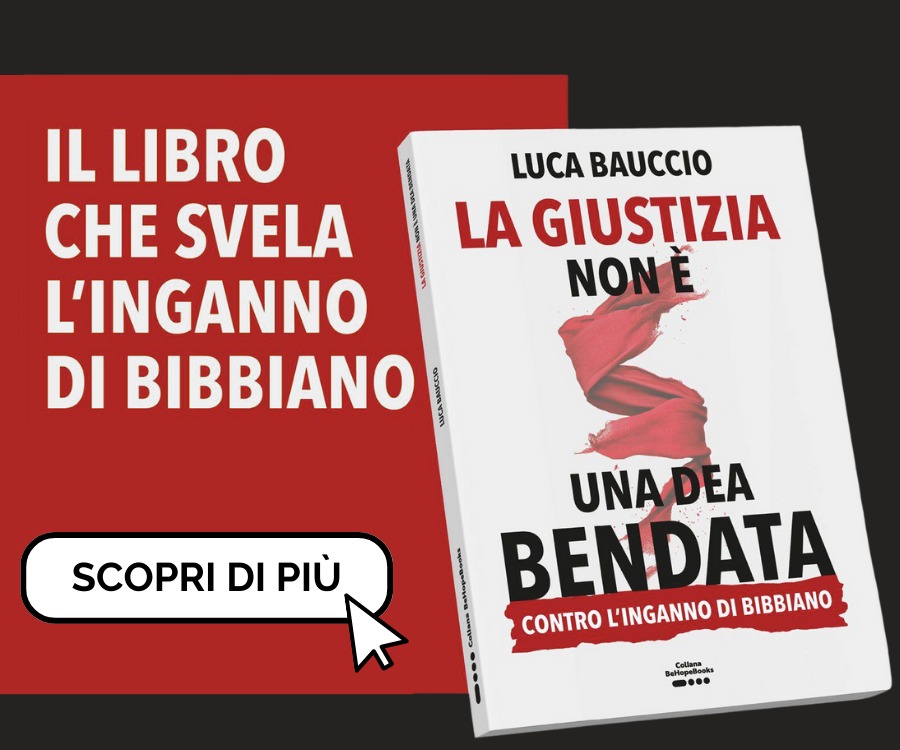PHOTO
Se c’è un’immagine simbolo della giustizia spettacolo, della gogna inutile, che scava, fino a corroderle totalmente, le vite umane, allora è quella di Enzo Tortora in manette, a favore di cronisti, dopo il suo clamoroso arresto all’Hotel Plaza di Roma. Per trasferirlo nel carcere di Regina Coeli, i militari aspettarono che fosse mattina, per garantire a cameramen e fotografi la prima fila per riprendere il presentatore con i ceppi ai polsi. Era il 17 giugno 1983 e cinque anni anni dopo, il 17 marzo del 1988, quando la Cassazione confermò l’assoluzione decisa in appello, quell’arresto si confermò ingiusto: Tortora era una vittima innocente della giustizia italiana e delle false accuse dei pentiti, che lo fecero rimanere per sette mesi in carcere portandolo poi, lentamente, alla morte.Quell’immagine, che avrebbe dovuto rappresentare un monito, sembra non aver insegnato nulla. Sono passati 32 anni, «ma non li dimostra», come disse poco tempo fa Francesca Scopelliti, compagna di Tortora e sua erede in quella battaglia per una giustizia giusta. Ne è la prova – se non altro – la continua esigenza di giornali e opinione pubblica di pronunciarsi prima dei giudici, di crocifiggere chiunque incappi nelle maglie della giustizia e di continuare a puntare il dito, ad alimentare il sospetto, anche dopo aver pagato il proprio debito con la giustizia o quando quel debito non lo si è mai avuto. L’arresto Tortora venne arrestato un venerdì all’alba, con un’accusa pesantissima: traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico. Lo accusavano due pentiti: Giovanni Pandico e Pasquale Barra, e un’agendina nera, trovata nell’abitazione di Giuseppe Puca, detto “‘o Giappone”, di professione camorrista, che riportava a penna un numero telefonico e a fianco un nome, che agli inquirenti sembrò quello del presentatore. Un appunto segnato distrattamente su un foglio, quasi indecifrabile, ma tanto è bastato, perché quel blitz, con 856 persone finite in manette, era un colpo grosso. E Tortora, con la sua voce che rimbombava in tv, con la sua faccia conosciuta da nord a sud del Paese, era il nome più importante di quel lungo elenco, anche se con tutto quel trambusto non c’entrava nulla.Quel nome divise il Paese. Da una parte c’era chi – in verità pochi – era convinto che fosse innocente. Dall’altra chi, prima ancora del processo, credeva già alla sua colpevolezza. Come Camilla Cederna, giornalista del Corriere della Sera, sicura che non potessero esserci errori sulla strada che aveva portato il conduttore da Portobello fino al carcere. «Mi pare che ci siano gli elementi per trovarlo colpevole: non si va ad ammanettare uno nel cuore della notte se non ci sono delle buone ragioni – scrisse -. Il personaggio non mi è mai piaciuto. E non mi piaceva il suo Portobello: mi innervosiva il pappagallo che non parlava mai e lui che parlava troppo, senza mai dare tempo agli altri di esprimere le loro opinioni». Bastava la sua antipatia o quella che per gli altri era tale, dunque, per non attendere nemmeno la pronuncia di un giudice. E perfino il suo sbigottimento al momento dell’arresto, scambiato per calma, era per alcuni una prova in più della sua colpevolezza: «Enzo Tortora rivela una calma addirittura sospetta al momento dell’arresto. Le labbra mosse con flemma, i muscoli del collo e della faccia tirati e la voce compassata sembrano voler ricordare e riprodurre a tutti i costi il personaggio del piccolo schermo, amato dalle massaie», scriveva su Il Tempo Marino Collacciani. Più prudenti furono Giorgio Bocca, Indro Montanelli e Enzo Biagi, il primo giornalista a battersi per lui, tanto da scrivere una lettera aperta al presidente della Repubblica Sandro Pertini. «Non le sottopongo il caso di un mio collega, ma quello di un cittadino – scriveva Biagi -. Non auspico un suo intervento, ma non saprei perdonarmi il silenzio. Vicende come quella che ha portato in carcere Enzo Tortora possono accadere a chiunque. E questo mi fa paura». L’agenda Peccato che su quell’agenda, accanto a quell’appunto informe, non ci fosse il numero del giornalista, bensì quello di una sartoria. Non solo: una perizia grafica dimostrò che quel nome, in realtà, era Tortona e non Tortora. Ma ciò non bastò, perché a “inguaiarlo” c’era anche la faccenda di alcuni centrini inviati da Pandico e altri detenuti a Pianosa alla redazione di Portobello perché fossero messi all’asta. Fu quello l’unico contatto con il “segretario” del boss Raffaele Cutolo, al quale il presentatore scrisse una lettera di scuse, inviando un rimborso di 800mila lire dopo aver appurato che la redazione aveva smarrito i centrini. Ma Pandico, schizofrenico e paranoico, cominciò a covare sentimenti di vendetta verso Tortora, sentimenti che tradusse in lettere sempre più minacciose, con lo scopo di estorcergli denaro.Fu lui il primo ad accusarlo, assieme a Pasquale Barra, sicario della camorra e assassino del boss Francis Turatello. E solo diversi mesi dopo decise di parlare di lui anche Giovanni Melluso, detto Gianni il bello, che 22 anni dopo, nel 2010, chiese scusa alla sua famiglia. Seguirono altre 16 persone, tra le quali il pittore Giuseppe Margutti, con precedenti per truffa e calunnia, e la moglie Rosalba Castellini, che raccontarono di averlo visto cedere stupefacenti già negli studi di Antenna Tre. La condanna e poi l’assoluzione in appello Tanto bastò per una prima condanna a 10 anni di carcere, pronunciata il 17 settembre del 1985. Il 26 aprile, il procuratore Diego Marmo – l’unico ad ammettere il suo errore, nel 2014 – nella sua requisitoria, definì Tortora, intanto eletto europarlamentare, un «cinico mercante di morte», diventato deputato «con i voti della camorra». Tortora si alzò in piedi per protesta: «È un’indecenza!», disse, guadagnandosi così anche un’accusa per oltraggio alla corte.Il 13 dicembre 1985 si dimise da europarlamentare e, rinunciando all’immunità, si confinò agli arresti domiciliari. L’assoluzione con formula piena in appello arrivò il 15 settembre 1986. I camorristi che lo accusarono finirono a processo per calunnia: secondo i giudici, infatti, alcuni avevano dichiarato il falso sperando di ottenere una riduzione della loro pena, altri, come Margutti, per avere notorietà. Michele Morello, il giudice che assolse Tortora, si accorse di quanto le accuse dei pentiti fossero sospette. «Ricostruimmo il processo in ordine cronologico – raccontò in un’intervista a “La storia siamo noi” – e ci rendemmo conto che queste dichiarazioni arrivavano in maniera un po’ sospetta. In base a ciò che aveva detto quello di prima, si accodava poi la dichiarazione dell’altro, che stava insieme alla caserma di Napoli. Andammo a caccia di altri riscontri in Appello, facemmo circa un centinaio di accertamenti. Di alcuni non trovammo riscontri, di altri trovammo addirittura riscontri a favore dell’imputato. Anche i giudici, del resto, soffrono di simpatie e antipatie… E Tortora, in aula, fece di tutto per dimostrarsi antipatico, ricusando i giudici napoletani perché non si fidava di loro e concludendo la sua difesa con una frase pungente: “Io grido: sono innocente. Lo grido da tre anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi da questo dibattimento! Io sono innocente, spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi”». La Cassazione sancì la sua innocenza il 17 marzo del 1987, un anno prima della sua morte, il 18 maggio del 1988. Il ritorno in tv Tortora tornò in televisione il 20 febbraio del 1987, riprendendosi il suo Portobello. Lo fece accolto da una standing ovation e un discorso rimasto nella storia della tv, la stessa che ora, comunque, lo dimentica. «Dunque, dove eravamo rimasti?», esordì con emozione. E il sospetto è di essere rimasti non troppo lontano dal 17 giugno di tanti anni fa.