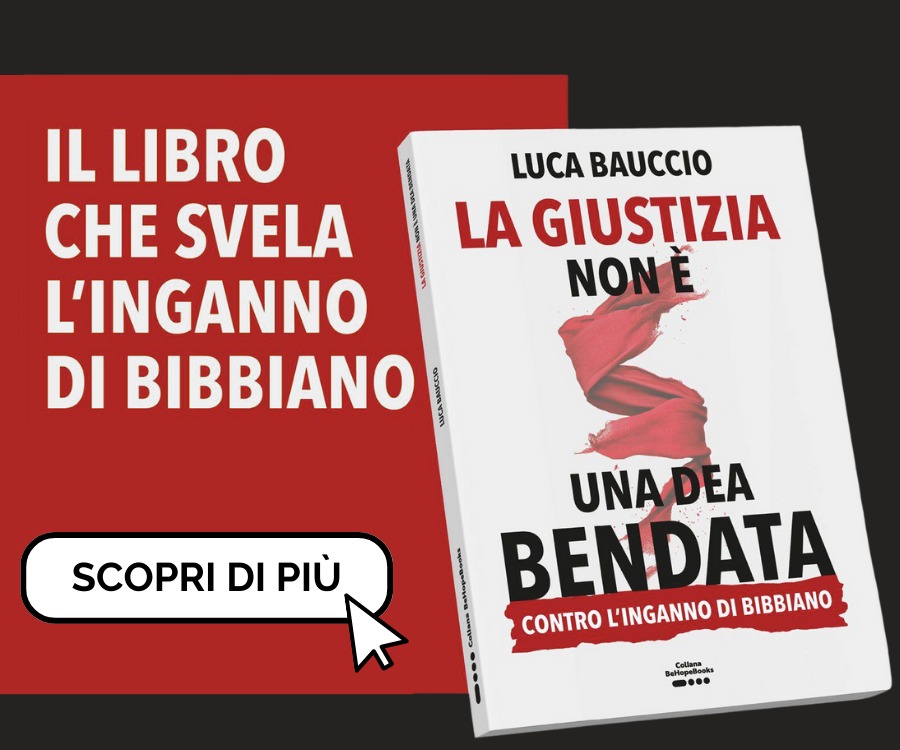PHOTO
“Ad un certo punto della vita non è la speranza l'ultima a morire, ma il morire è l'ultima speranza”, diceva Leonardo Sciascia. Una frase che sembra riassumere la storia di Piergiorgio, Eluana, Fabo e tutti gli altri nomi diventati simbolo di una battaglia per i diritti. Quello di avere una vita dignitosa, quello di porre fine alla sofferenza. Il diritto di scegliere come vivere e come morire.
Un diritto finora negato, strappato quasi con la forza da chi negli ultimi 13 anni ha provato a trasformare il proprio dolore in un insegnamento, nonostante le fatiche del corpo. «Quando la vita non è più vita, ma è solo un movimento del cuore, respirazione, digestione, ma non si ha più il contatto, la partecipazione, la gioia di stare con gli altri, allora non c’è più davvero vita, non c’è più dignità. Ed è il momento di lasciar andare», diceva al Dubbio, qualche mese fa, Mina Welby, moglie di Piergiorgio. Parole pronunciate all’indomani del parere del Comitato nazionale di Bioetica, che ha aperto alla legalizzazione del suicidio medicalmente assistito in Italia, distinguendolo dall'eutanasia, dandole la speranza di poter vincere la battaglia iniziata dall’uomo che ha amato tanto da aiutarlo a morire.
La prima storia di questo lungo percorso è proprio quella di Piergiorgio Welby, che la sua battaglia l’ha vinta il 20 dicembre 2006, giorno in cui è morto. Attivista, giornalista e co- presidente dell'Associazione Luca Coscioni, fu affetto da distrofia muscolare in forma progressiva fin dai 16 anni. Una malattia che, poco per volta, gli impedì di camminare a parlare, costringendolo, nello stadio finale, immobile su un letto, pur rimanendo sempre lucido. Accanto a lui Mina Welby, alla quale Piergiorgio, tracheotomizzato e attaccato ad un respiratore, chiese più volte di staccare la spina. Una richiesta che, però, era in contrasto con le leggi.
Così iniziò la sua battaglia politica, aprendo un forum dedicato all’eutanasia in uno spazio concessogli dai Radicali, che lo elessero co- presidente dell'Associazione Luca Coscioni. Dal suo letto chiese all'allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il diritto all'eutanasia, spiegando tutta la sua sofferenza. «Io non sono né un malinconico né un maniaco depresso – scrisse - morire mi fa orrore, purtroppo ciò che mi è rimasto non è più vita, è solo un testardo e insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche. Il mio corpo non è più mio… è lì, squadernato davanti a medici, assistenti, parenti».
Ma il 16 dicembre del 2006 il tribunale di Roma si oppose alla richiesta di interrompere l'accanimento terapeutico, a causa del vuoto legislativo in materia. E per morire, a Piergiorgio toccò contare sulla disobbedienza civile di un medico, l’anestesista Mario Riccio, che su richiesta di Piergiorgio, dopo avergli somministrato dei sedativi, il 20 dicembre 2006 staccò il respiratore che lo teneva in vita, vincendo definitivamente la sua battaglia con la vita. Ma non con la Chiesa, che negò i funerali religiosi a Welby, colpevole di essere un «suicida». Riccio fu stato prima incriminato e poi prosciolto.
Da quel momento iniziò un percorso lungo e travagliato, che ha condotto, dopo tanti anni, prima alla legge sul Biotestamento, poi ai processi che oggi hanno portato la questione davanti alla Consulta. Un percorso lunghissimo, la cui seconda tappa è la storia di Giovanni Nuvoli, ex arbitro e agente di commercio di Alghero, morto il 24 luglio 2007 dopo aver chiesto più volte di poter staccare il respiratore.
«Voglio morire senza soffrire, addormentato», diceva a sua moglie. Il 10 luglio 2007, il medico anestesista Tommaso Ciacca stava per eseguire le sue volontà, ma fu bloccato dai carabinieri di Alghero e della procura di Sassari. Così, dal 16 luglio, per otto giorni, Nuvoli iniziò uno sciopero della sete e della fame che lo portò alla morte, nella sala di rianimazione allestita nella sua villetta alla periferia di Alghero, quando il suo corpo pesava ormai soltanto 37 chili. Al momento della morte aveva ancora attaccato il respiratore artificiale che lo teneva in vita.
Poi è stata la volta di Eluana Englaro, la cui storia spaccò definitivamente l’opinione pubblica. Una giovane donna la cui vita fu stroncata a 20 anni, il 18 gennaio 1992, quando dopo un incidente d'auto entrò in uno stato vegetativo permanente, di fatto incapace di interagire con il mondo circostante, immobilizzata in una clinica di Lecco e alimentata con un sondino nasogastrico. Fu suo padre, Beppino Englaro, ad impegnarsi per staccare la spina e rispettare un desiderio espresso in vita dalla giova- ne: la volontà, in caso di una condizione simile a quella in cui si trovava, di non ricorrere a nessun accanimento terapeutico.
Dopo 12 mesi di attesa, i medici comunicarono che per lei non c’era più niente da fare: il cervello era ormai andato incontro a una degenerazione definitiva. Nessuna possibilità di recupero, dunque, nessuna possibilità di sentire ed entrare in contatto con il mondo esterno. Eluana era già morta. Così iniziò la battaglia di Beppino: si rivolse ad avvocati, magistrati, al presidente della Repubblica. Ma nel 1999 il Tribunale di Lecco respinse le sue richieste, così come, successivamente, fece la Corte d’Appello di Milano. Sempre un no dai tribunali, fino al 16 ottobre 2007, quando la Cassazione rinviò la decisione alla Corte d’appello di Milano. E da lì la svolta: il 9 luglio 2008 i giudici autorizzarono la sospensione dell’alimentazione per via di uno stato vegetativo irreversibile. Ma contro la libertà tanto cercata da Beppino Englaro si mossero associazioni, comitati etici e politici. E nessun ospedale, intanto, era disposto a prendersi la responsabilità di interrompere le terapie.
Opposizioni che arrivarono anche dalla Regione Lombardia e dalle Camere, che sollevarono un conflitto di attribuzione contro la Corte di Cassazione. Ma quei ricorsi furono giudicati inammissibili dalla Corte Costituzionale, l’ 8 ottobre del 2008. Il 22 dicembre del 2008 l’ultimo verdetto: la Corte europea per i diritti dell’uomo respinse il ricorso di diverse associazione contro il decreto della Corte d’appello di Milano che autorizzava il distacco del sondino per l’alimentazione artificiale. Così Eluana fu libera di morire, il 9 febbraio 2009, in una clinica di Udine, dopo che il governo Berlusconi aveva tentato di emanare un decreto legge ad hoc».
Nel 2015 fu Walter Piludu, ex presidente della Provincia di Cagliari e dal 2013 malato di Sla, a chiedere alla politica una legge sul fine vita, di fatto riaprendo il dibattito. Malato di sclerosi laterale amiotrofica dal 2011, dal 2012 al 2016 redasse una serie di scritture private chiedendo di evitare, in caso di perdita della capacità di autodeterminarsi, cure invasive volte a prolungare la sua vita, fino a delegare l’amministratore di sostegno ad individuare un medico che procedesse, previa sedazione, al distacco del respiratore.
Una chiara disposizione delle proprie volontà, che il 31 maggio 2016 fu portata dall’amministratore di sostegno davanti al Tribunale di Cagliari, assieme ad una richiesta per ottenere l’autorizzazione al distacco dei presidi medici vitali. Una richiesta accolta dal giudice, che così consentì a Piludu di morire, dopo l’interruzione della ventilazione polmonare. Era il 3 novembre 2016.
Infine è toccato a Dj Fabo, al secolo Fabio Antoniani, morto il 27 febbraio 2017. Dj Fabo era cieco e tetraplegico dall'estate del 2014, a causa di un gravissimo incidente stradale. Alla clinica “Dignitas di Forck”, vicino Zurigo, ci arrivò accompagnato da Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni. Fu proprio quel viaggio in Svizzera a portare Cappato in un’aula di Tribunale a Milano, dalla quale poi è arrivata la richiesta alla Consulta di chiarire se aiutare un uomo a morire sia un reato o meno. «Ha morso un pulsante per attivare l'immissione del farmaco letale - raccontò Cappato -, era molto in ansia perché temeva, non vedendo il pulsante essendo cieco, di non riuscirci. Poi però ha anche scherzato».
Durante il processo a Cappato, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano aveva messo in dubbio la validità di una norma che, ad oggi, appare anacronistica. Marco Cappato, aveva detto durante la sua requisitoria, non ha aiutato nessuno a suicidarsi, ma soltanto ad esercitare il proprio «diritto alla dignità». Dj Fabo rifiutò l’alternativa italiana, la sospensione delle cure, che pure il Radicale aveva prospettato ad Antoniani, chiedendo fino all’ultimo se fosse convinto della sua decisione.
Durante la requisitoria Siciliano aveva, di fatto, esortato la politica ad agire, richiamando la necessità di un intervento legislativo in grado di chiarire i limiti dell’articolo 580 del codice penale. «Sarebbe meglio se una certezza venisse data da un intervento legislativo che fissasse i limiti per accedere al suicidio assistito, come succede in Svizzera, dove c'è una straordinaria serietà nel farlo», aveva evidenziato la pm.
Ed in Svizzera, Cappato e Welby hanno accompagnato anche Davide Trentini, malato di sclerosi multipla, morto il 13 aprile 2017, morte per la quale i due Radicali sono oggi a processo.
Oltre a Cappato, insieme ad Antoniani, il giorno della sua morte, c’erano la madre, la fidanzata e gli amici più stretti. Era stato lui stesso, con un video messaggio, a raccontare il suo arrivo in Svizzera. «Ci sono arrivato, purtroppo, con le mie forze e non con l’aiuto del mio Stato», disse poco prima di iniziare il percorso verso la morte. E prima di andarsene descrisse la sua situazione come «un inferno di dolore», dal quale è sfuggito soltanto con l’aiuto di Cappato. Purtroppo, aveva aggiunto, «rispettando le regole di un Paese che non è il suo».