PHOTO
L’intervento del vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli al convegno su “Giustizia al Servizio del Paese - La prevedibilità delle decisioni” tenutosi a Lecce
++++
Nell’interrogarci su quanto possano oggi dirsi prevedibili le decisioni delle nostre Corti, possiamo muovere dalla considerazione secondo cui la Carta costituzionale non prevede una gerarchia dei valori; nessuno di essi è sovraordinato, nessuno di essi si sottrae al bilanciamento e diviene “tiranno” rispetto agli altri: neppure la certezza del diritto, che è un precipitato del principio di legalità, e che si traduce per i consociati nella concreta prevedibilità delle conseguenze giuridiche delle proprie azioni.
Nondimeno, la certezza del diritto ha una tale decisiva importanza che il giurista non può non riconoscerle una posizione privilegiata. Per ragioni storiche: come ha scritto Massimo Luciani, la certezza del diritto «è la proiezione giuridica dell’essenza politica della statualità moderna»; essa esprime quell’aspirazione all’ordine che è il tratto distintivo essenziale del pensiero politico occidentale.
Ma la certezza del diritto ha una posizione privilegiata anche per ragioni funzionali, collocandosi all’incrocio fra tre princìpi che, certo non casualmente, compaiono nei primi tre articoli della Costituzione: la democrazia, la libertà, l’eguaglianza.
Essa è funzionale alla democrazia, perché solo un’applicazione delle fonti prevedibile conserva l’efficacia precettiva della legge, espressione della volontà della rappresentanza liberamente eletta. È funzionale alla libertà, perché solo potendo prevedere le conseguenze giuridiche delle proprie azioni il singolo è libero di orientarsi nell’una o nell’altra direzione.
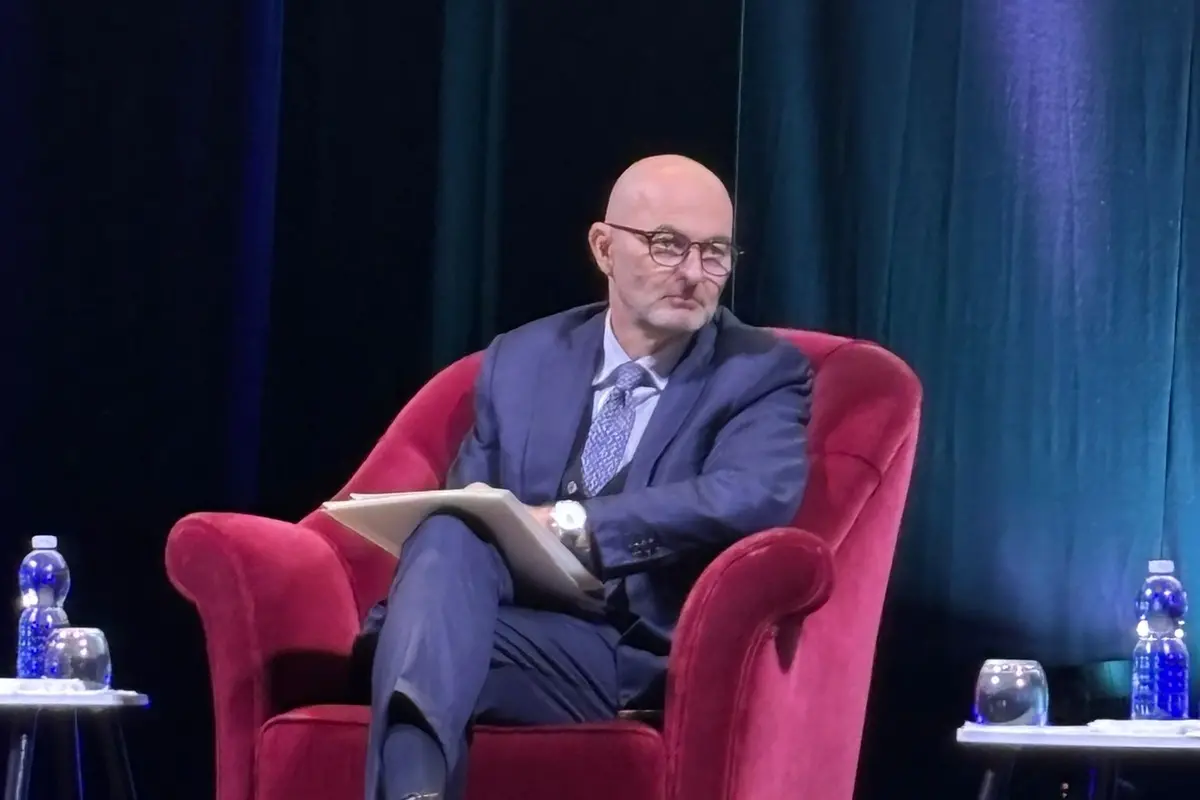
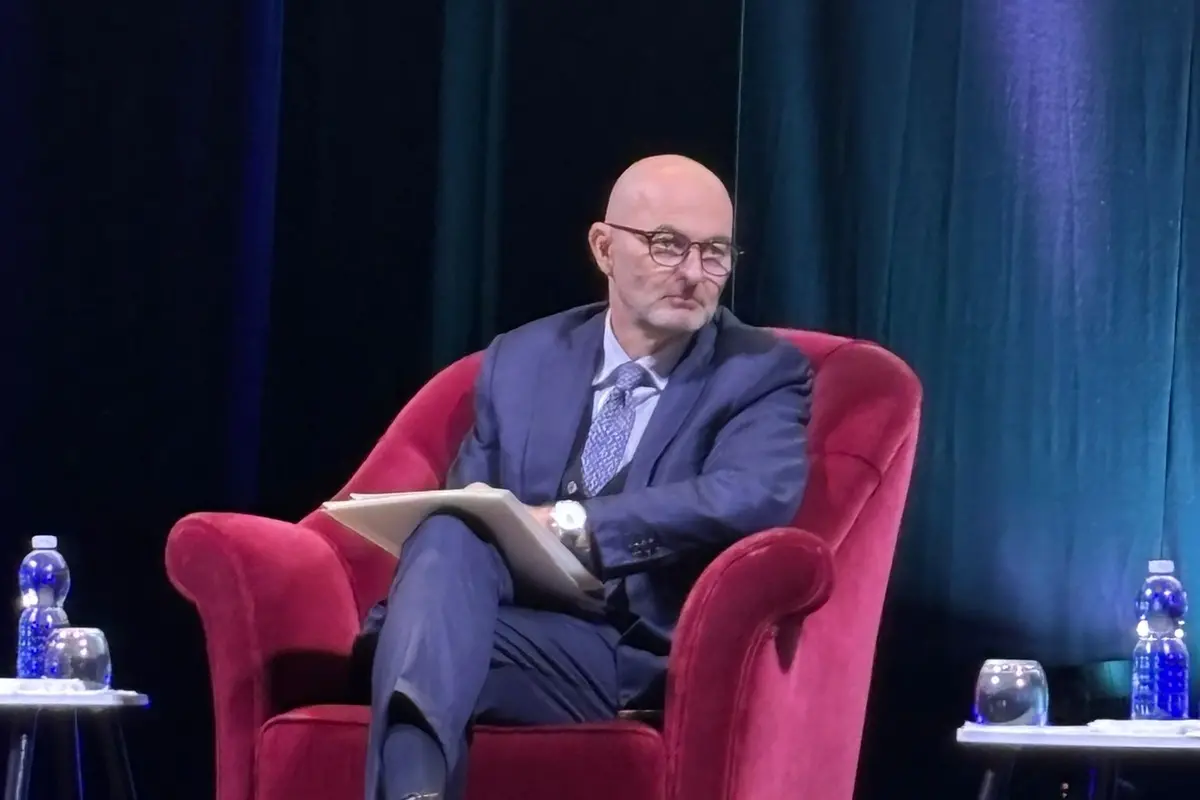
È funzionale all’eguaglianza, perché fenomeni quali l’inaspettata retroattività della legge o l’imprevedibile oscillazione della sua interpretazione non solo generano incertezza, ma introducono anche il concreto rischio di trattare fattispecie identiche in modo difforme.
Nella recente sentenza n. 13 del 2022, relatore l’attuale Presidente Amoroso, la Corte costituzionale ha definito la certezza del diritto la «pietra d’angolo del sistema di tutele giurisdizionali in uno Stato di diritto»: la sentenza, nel rimarcare che le disposizioni sulla nomofilachia dettate nei tre diversi plessi di giurisdizione sono ispirate dalla stessa esigenza di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, ha enfatizzato la persistente centralità del valore della certezza del diritto.
Pietra d’angolo, dunque, ma anche pietra d’inciampo: forse mai come ai giorni nostri un sentimento di profonda incertezza pervade gli operatori del diritto ed i comuni cittadini.
Le cause della moderna crisi della legalità sono molteplici. Vi sono cause macro-sociali, riconducibili essenzialmente al contrasto tra la crescente esigenza di regolamentazione normativa derivante dall’evoluzione della società, ed il progressivo indebolimento del decisore politico, che si rivela sempre più in difficoltà nel formulare strategie normative di lungo respiro e di ampio orizzonte.
Troppo spesso la politica legislativa, smarrita quella forte nervatura un tempo derivante dalle ideologie, licenzia testi che non riescono ad esprimere precetti chiari e comprensibili, e che inevitabilmente aprono la strada al creazionismo giudiziale: il «nascere e morire di norme senza unitaria ragione e senza durata», come ha scritto Natalino Irti a proposito di quello che ha definito come «occasionalismo legislativo», fatalmente costringe la giurisprudenza a ricercare soluzioni che la politica non ha saputo definire in maniera netta e puntuale.
Non possiamo, tuttavia, nasconderci che il creazionismo giudiziale ha spesso tutt’altra genesi, ed è direttamente riconducibile a motivi che potremmo definire giuridico-costituzionali.
Si tratta di un’inevitabile conseguenza del passaggio dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale di diritto. Con un’efficace immagine, questa trasformazione è stata illustrata facendo riferimento a due figure geometriche, consistenti l’una in una linea retta e l’altra in un triangolo.
Lo Stato di diritto, il suo sistema istituzionale e delle fonti, possono essere rappresentati da una linea retta, lungo la quale si “scende” dalla Costituzione alla legge e poi al giudice e al suo dictum; in questa raffigurazione è evidente che il giudice non parla direttamente con la Costituzione, ma lo fa solo per il tramite della legge, applicando esclusivamente quest’ultima.
Lo Stato costituzionale di diritto è invece raffigurabile come un triangolo: al suo vertice sta la Costituzione, mentre alla sua base stanno, da un lato, la legge e, dall’altro, la giurisdizione. Lungo i due lati del triangolo la Costituzione “scende” tanto verso il legislatore quanto verso il giudice, che, dunque, dialoga direttamente con la Costituzione anche senza l’intermediazione della legge.
È, questa “triangolare”, una concezione assai più dinamica e forse anche più affascinante del diritto. La sua fisiologia sta in un rapporto non più antagonistico, ma di armonica cooperazione tra legge e giudice, nel segno della Costituzione. Il rischio che questo sistema porta con sé è quello che la giurisprudenza - attuando la «tutela dell’indirizzo politico istituzionale», come sancì l’Associazione Nazionale Magistrati in chiusura dello storico congresso di Gardone del 1965 – possa essere indotta a svalutare il dato letterale e a misurare l’interpretazione della norma sulle esigenze della giustizia del caso concreto, così alimentando l’imprevedibilità delle decisioni: si pensi, nel diritto penale, all’istituto del concorso esterno nell’associazione mafiosa, o al sempre più frequente ricorso alla colpa generica “residua” in campo infortunistico, che, come ha ben sottolineato qualche giorno fa il Presidente emerito Giovanni Maria Flick, rischia di rimodellare la responsabilità nel diritto penale d’impresa ricorrendo a schemi nei quali riecheggiano forme di responsabilità oggettiva.
Il fenomeno che Paolo Grossi ha descritto come «lo spostamento dell’asse portante dell’ordinamento dal legislatore all’interprete» presuppone, dunque - perché su questo altare non venga irrimediabilmente sacrificata la certezza del diritto - che non si faccia un uso disinvolto della funzione ermeneutica.
Lo scivolamento dalle parole della legge alle ricostruzioni interpretative che ne sviliscono la portata, in un ordinamento che non conosce la regola dello stare decisis, finirebbe, infatti, per aumentare la gamma delle possibili letture delle norme, provocando una duplice scia di conseguenze negative: non solo l’artificioso incremento dei contrasti giurisprudenziali, ma anche l’indebolimento delle funzioni cognitive e garantistiche del processo, poiché l’incertezza semantica incrina la connessione tra regola e giudizio, rendendo problematiche le valutazioni delle parti nelle opzioni probatorie e nella scelta dei riti, sfiancando l’effettività del contraddittorio ed oscurando i profili di giustizia della decisione.
Si avverte, allora, la necessità di una rigenerazione culturale non solo della legislazione (chiamata ad abbandonare la delega oggi di fatto conferita al formante giurisprudenziale, per il tramite di clausole normative e di elementi descrittivi che hanno un campo semantico troppo spesso ambiguo), ma anche della giurisprudenza.
Sarebbe certo antistorico pretendere che il giudice si limiti ad essere “bocca della legge”. E tuttavia, sarebbe sbagliato non sottolineare che l’odierno assetto ordinamentale ha accresciuto l’esposizione politico istituzionale della magistratura: un’esposizione comunque nociva, perché ne mette a rischio la percezione di imparzialità e la conseguente fiducia che in essa ogni consociato deve nutrire. Tutto ciò impone l’acquisizione non solo di una ancor più solida preparazione tecnico giuridica, ma anche di un’accresciuta consapevolezza critica del ruolo e degli effetti del proprio agire da parte di ogni magistrato: il raggiungimento dell’obiettivo della certezza del diritto, richiamato di recente anche dal Presidente emerito Augusto Antonio Barbera con il suo rigoroso monito sugli «eccessi valoriali» della giurisprudenza, dipende anche e soprattutto dal contributo che ogni singolo magistrato saprà fornire, nel quotidiano esercizio della funzione giudiziaria, per evitare collisioni ed interferenze col senso più autentico e profondo della legalità legislativa.
Questo assetto è venuto ulteriormente a complicarsi in conseguenza del nuovo mutamento di paradigma che abbiamo dovuto registrare nel nostro tempo: dallo Stato costituzionale di diritto ci si è, invero, mossi verso quello che alcuni Autori hanno definito lo Stato costituzionale di diritto sovranazionale.
Come ben sappiamo, l’ordinamento convenzionale non aspira a legittimare una diversa modalità di produzione del diritto, alternativa al sistema della legalità parlamentare, poiché si propone di assicurare in concreto la garanzia dei diritti di libertà propri della tradizione giuridica occidentale.
Abbiamo così assistito alla sovranazionalizzazione dei diritti fondamentali, che trovano riconoscimento, non sempre in modo uniforme, in plurime fonti internazionali alle quali è riconosciuta forza vincolante nei confronti degli Stati, sulla cui osservanza vigilano attentamente le Corti sovranazionali.
Nello Stato di diritto e nello stato costituzionale di diritto l’autorità creava la legge e poi la applicava secondo la propria discrezionalità, da esercitarsi entro i canoni della ragionevolezza; oggi, invece, l’autorità statale, sottoposta alla giurisdizione ed al controllo costante delle Corti sovranazionali, deve dimostrare che le sue norme rispettano gli obblighi di tutela imposti a salvaguardia dei diritti fondamentali.
Dunque, il potere giudiziario dialoga direttamente con le Corti sovranazionali, che ragionano secondo meccanismi di common law ed emanano sentenze vincolanti per tutti gli ordinamenti nazionali; questi ultimi vi si devono adeguare e devono far prevalere il contenuto di tali sentenze persino sulle loro leggi ordinarie, con i soli limiti, anzi, sarebbe meglio dire i controlimiti che la paziente e preziosa opera della Corte costituzionale individua al fine di garantire il costante equilibrio tra il procedimento di integrazione europea e la salvaguardia dei caratteri peculiari ed irrinunciabili dell’ordinamento statale.
Nello stesso momento in cui ci si ferma a considerare gli indiscussi benefici di questo sistema, che assicura una più incisiva tutela ai diritti fondamentali delle persone, ci si deve chiedere come il sostanziale spostamento del baricentro del diritto, dal momento creativo-legislativo a quello giurisprudenziale-applicativo, impatti sulla certezza del diritto.
I fattori che in questo contesto rischiano di rendere sempre meno prevedibile la decisione sono molteplici. È divenuta ardua già la prima e fondamentale operazione, ossia l’individuazione, nella mutata e complessa gerarchia delle fonti multilivello, delle norme applicabili; lo schema sillogistico, che guidava e rassicurava l’interprete, è stato affiancato da un ulteriore schema interpretativo: il giudice non si limita più all’operazione meccanicamente sussuntiva, ma procede prima di tutto all’invenzione della norma, nel senso letterale ed etimologico precisato da Paolo Grossi, come inventio, ossia scoperta, rinvenimento; il giudice svolge, cioè, una preliminare attività di ricerca, per trovare una norma che, pur “circolando” nell’ordinamento, non è autoevidente nell’espressione verbale della legge; in sostanza, nel sistema della pluralità delle fonti, in cui l’esistenza di ogni norma è la risultante del suo rapporto con le altre, il giudice non ha più immediatamente a disposizione la norma da applicare, ma la deve individuare, con complesse operazioni di natura valutativa, nel “labirinto” delle molteplici norme che, talvolta dotate di contenuti e scopi tra loro diversi, insistono sulla stessa materia.
Numerosi sono, poi, gli strumenti a disposizione del giudice: le questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale ed europea, che, seppure attribuendo a Corti centrali l’individuazione definitiva del contenuto normativo, impegnano in prima battuta il giudice a quo in complesse attività valutative propedeutiche; la disapplicazione della norma interna incompatibile col diritto eurounitario e, ancora di più, l’interpretazione conforme, che fanno del giudice un “inventore” attivo della norma da applicare, relegando il momento sussuntivo ad un posterius assai meno rilevante. Il giudice diviene, allora, necessariamente partecipe del processo di produzione del diritto effettivo, ben al di là dei cancelli costituiti dalla legge, sempre suscettibile di essere messa in discussione nella selva del sistema multilivello delle fonti.
Accade così che, in presenza di una sentenza della Corte di Giustizia che esprime un principio prevalente su una legge ordinaria, si può dare spazio ad interpretazioni conformative ai dati sovranazionali, si può disapplicare la legge, si possono effettuare operazioni di re-interpretazione delle categorie giuridiche tradizionali, anche forzando il dato normativo per far prevalere gli scopi e i principi fissati dal diritto unionale (si pensi alla sentenza delle Sezioni unite civili del 2023 che, per adeguare il nostro ordinamento ai principi di primazia della tutela del consumatore fissati dalla Corte di Giustizia, ha effettuato quella che molti Autori hanno definito un’interpretazione creativa delle norme del codice di procedura civile in materia di opposizione a decreto ingiuntivo).
Il diritto prevedibile è figlio dell’illuminismo francese e dell’età della codificazione. Indebolito il primato della legge statale, è svanita l’illusione che la decisione dovesse rappresentare il mero precipitato logico dell’operazione sillogistica di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta.
L’emergere di nuovi bisogni e di nuovi diritti in una società che si evolve sempre più velocemente, ponendo nuovi problemi con una rapidità tale che il legislatore non è in grado di risolverli tempestivamente, la globalizzazione, il passaggio dal dominio della tradizione a quello della razionalità hanno segnato il definitivo tramonto della modernità giuridica e dell’ideale illuministico del diritto chiaro e preciso, e l’irrompere della cosiddetta pos-modernità, in cui il diritto è «frutto di invenzione».
Il diritto imprevedibile è un portato quasi inevitabile di un contesto nel quale la complessità sociale si è tradotta in complessità giuridica, e la primazia della legge statale si è persa in un sistema che conosce un numero significativo di fonti provenienti da autorità diverse.
L’impegno della comunità dei giuristi deve essere quello di evitare l’ulteriore, drammatico, passaggio dal diritto imprevedibile al diritto irriconoscibile, nel quale l’intreccio inestricabile di interventi multilivello non gerarchicamente ordinati, di fonti nazionali e convenzionali, di sentenze delle nostre Corti e di quelle sovranazionali, rischia di mettere in ombra la stessa effettività della tutela giurisdizionale, rendendo non immediatamente intellegibile l’individuazione del rimedio approntato dall’ordinamento per risolvere le antinomie tra le diverse norme: non di rado diviene operazione improba il pronosticare se in determinati casi il giudice comune perverrà ad una disapplicazione diretta di norme nazionali in contrasto con il diritto unionale, oppure solleverà questioni pregiudiziali interpretative davanti alla Corte di Giustizia, oppure ancora solleverà questioni di legittimità costituzionale (si pensi alle recentissime vicende in materia di trattenimenti dei richiedenti asilo e di individuazione dei cosiddetti “paesi sicuri”).
Ove a ciò si aggiunga la constatazione che spesso non solo non vi è sovrapponibilità, ma vi è proprio distanza tra i criteri che orientano il giudizio delle diverse Corti che si pronunciano sugli stessi fatti, si rischia di dover concludere nel senso che oggi deve parlarsi non più di imprevedibilità delle singole decisioni, bensì di una vera e propria imprevedibilità di sistema (si pensi alla recentissima sentenza Isaia contro Italia, dello scorso 25 settembre, con la quale i giudici di Strasburgo hanno rimesso in discussione princìpi e conclusioni che sembravano consolidati in tema di confisca di prevenzione).
La complessità non può diventare causa di irrisolvibile incertezza. È interesse di tutti - della politica, della magistratura, della avvocatura e della accademia - profondere ogni sforzo per fronteggiare questi rischi, per contribuire a recuperare certezza, per ricostruire confini sicuri e stabili al ruolo di ciascuno, e, in ultima analisi, per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.


