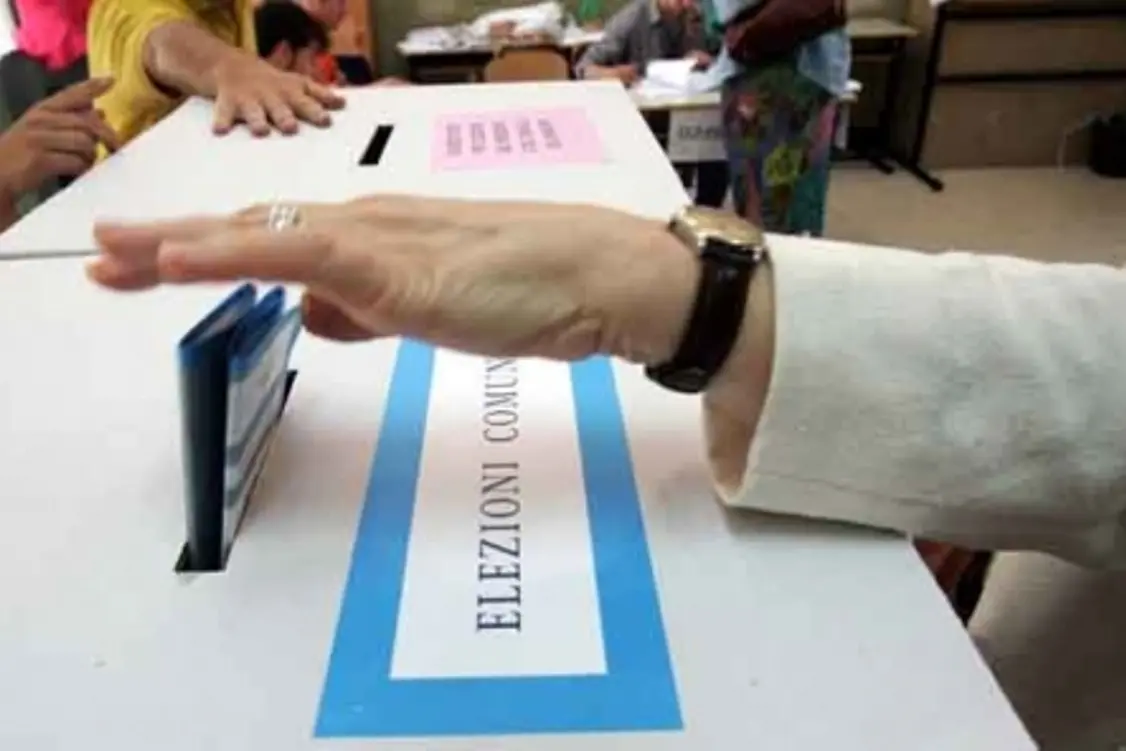PHOTO
L’editoriale di venerdì scorso del direttore de il Dubbio sull’ alienazione della politica dalla vita dei cittadini sollecita una riflessione sul rapporto ormai interrotto tra Parlamento e territori. L’enfasi di questi ultimi anni sull’art. 67 della Costituzione e sull’assenza di un vincolo di mandato tra eletti e elettori è figlia di una lettura parziale della nostra legge fondamentale. I costituenti enfatizzarono negli articoli sui “rapporti politici” l’espressione di una partecipazione effettiva e piena di tutto il corpo sociale alla vita politica e parlamentare e vollero segnare una discontinuità con l’ “Italietta Giolittiana” che fu incapace di resistere al fascismo.
In questo spirito il parlamentare non doveva più solo rappresentare gli interessi di un territorio ( questo lo si dava per scontato), ma esprimere “la Nazione”, concetto mazziniano e romantico per significare che ogni deputato e senatore è espressione della Repubblica e del suo dovere di farsi carico della sintesi unitaria dei contrapposti interessi e sensibilità presenti in Italia. C’ è chiaramente nella formulazione dell’articolo 67 della Costituzione l’eco dell’etica hegeliana rivisitata in chiave crociana, mazziniana e marxista, che non poca parte ebbero della cultura di quegli anni.
Un’idea nobile, ma poco pragmatica, che dette per scontato ciò che poi non è stato : lo stretto legame tra eletti ed elettori nella democrazia. Certo, durante la Prima Repubblica il problema non si pose : i deputati erano ospiti fissi di matrimoni e prime comunioni nel loro collegio , specialmente quando la primavera portava il profumo di elezioni ed erano solleciti a difendere a spada tratta minuscole Preture e piccole Stazioni ferroviarie nei loro territori.
Quando i loro elettori venivano a Roma, per udienze papaline in Vaticano o adunate in Piazza San Giovanni erano solleciti nel riceverli nella Capitale e a mostrare luogo i palazzi del potere, ostentando di essere influenti in stanze, dove magari in altri giorni passavano inosservati anche ai commessi.
La fine dei partiti e il sostanziale abbandono del sistema maggioritario con i suoi piccoli collegi, utile a radicare un candidato nel territorio, ha creato una voragine incolmabile tra politica e popolo.
Oggi è normale per un romano essere eletto a Firenze o in Sicilia senza neppure averci fatto una vacanza : si vota un listone di nomi sotto il simbolo e il nome del Capo.
Un sistema del genere è chiaramente antidemocratico e autoreferenziale . Richiamare l’istituto giuridico del “mandato con o senza rappresentanza” e discettare sul punto, non coglie il senso di una crisi più profonda.
Quella di un Parlamento alieno dal “Paese Reale” più ancora che nell’Italia liberale degli inizi del Novecento con il suo suffragio censitario e sessista.
Per pochi che fossero quegli elettori erano comunque un riferimento per gli eletti, che comunque erano consapevoli di dover render conto a qualcuno e di confrontarsi con una possibile alternativa, come illustra magistralmente Di Roberto nei Vicerè.
Oggi la carriera di un parlamentare è tutta una questione “romanesca”, che si gioca in pasticciacci e manovre , culminate in minacce tipo “ti massacreremo“, che fanno pensare più a storie di ragazzi di vita che agli interessi della Nazione.
Solo la fine delle liste bloccate e un maggioritario “secco” con collegi ristretti può farci uscire dalla palude; magari servirebbero anche Hegel, Croce e Federico Chabod per capire che cosa vuol dire Nazione.
Ma forse è chiedere troppo